- Abstract
- Introduzione – L'India Britannica e i Musulmani
- La Schiavitù – Una Pratica Islamica Consolidata
- La Reazione dei Conservatori
- Mawdudi – Un Sapiente Mainstream
- Dagli anni Settanta ai Nostri Giorni – Una Posizione Costante
- ISIS e Boko Haram – Il Volto Moderno della Schiavitù nell'Islam
- Conclusioni
- Letture Consigliate
Abstract
Nel XIX secolo, in India si formano dei movimenti che cercano di riformare e (quasi abolire) la schiavitù, e che vengono contrastati dagli elementi conservatori della comunità islamica (la maggior parte); attualmente, la schiavitù rimane un aspetto controverso e mai abrogato dell’Islam, e alcuni gruppi, come ISIS, Boko Haram (e probabilmente anche Hamas) la praticano ancora, apertamente o in forme più subdole (retorica degli ostaggi, tenuti ancora in tale condizione dopo un anno e mezzo di conflitto).
In the 19th century, movements emerged in India seeking to reform and (almost abolish) slavery, which were opposed by the conservative elements of the Islamic community (the majority); currently, slavery remains a controversial and never-abrogated aspect of Islam, and some groups, such as ISIS, Boko Haram (and probably also Hamas), still practice it, openly or in more insidious forms (hostage rhetoric, kept in such conditions even after more than a year and a half of conflict).
Introduzione – L’India Britannica e i Musulmani
La conquista britannica del continente indiano, che si consolida nel corso del XIX secolo, specialmente dopo la soppressa rivolta dei Sepoy nel 1857, ha impresso un forte condizionamento sulla vita dei musulmani che vivevano in quest’area nel periodo storico in esame. Si tratta di una dinamica simile a quella delle Indie Orientali Olandesi, il cui potere sulla colonia tropicale si consolida proprio nello stesso periodo. Dopo il 1857, cessa il governo indiretto della Compagnia delle Indie e inizia quello diretto della corona britannica, in maniera simile a quanto accade nelle Indie Olandesi nel 1800, con la cessazione della VOC e l’inizio del dominio diretto dei Paesi Bassi.

Tra le istanze che emergono, e che rimangono problematiche, emerge quella della schiavitù, un’istituzione che nell’attuale India esisteva da secoli, sia nelle aree islamiche che induiste; per questa ragione, sembra interessante comprendere quale fosse la posizione dei musulmani ‘indiani’ (intesi come abitanti dell’attuale India) rispetto a tale questione. Prima di addentrarci nei dettagli di questa istanza, tuttavia, sembra utile proporre una breve panoramica della situazione dei musulmani in questo periodo storico.
Il punto di svolta fondamentale del dominio britannico in India, probabilmente, consiste nella ribellione del 1857, soppressa dalle autorità coloniali non senza una certa fatica; questo evento, ben noto, documentato e analizzato dalla storiografia, ha comportato, tuttavia, un elemento che spesso viene taciuto, ignorato o poco compreso. Si tratta del processo politico all’ultimo imperatore dei Mughal, Bahadur Shah. Tale evento, in effetti, ha segnato l’apice del tentativo di legittimare l’amministrazione britannica in India, ed ha avuto l’effetto, tuttavia, di alimentare un nazionalismo che avrebbe poi portato all’indipendenza della nazione, anche se quasi un secolo dopo.
La Schiavitù – Una Pratica Islamica Consolidata
Nel mondo islamico, il dibattito sulla schiavitù, sia tra i teologi che tra i fedeli, è antico, e non sorprende che in alcune aree siano sorti dei ‘quasi movimenti’ di abolizione di questa pratica millenaria; la maggior parte dei sapienti islamici, effettivamente, giustificava (formalmente) la schiavitù solamente in seguito ad una guerra ‘contro gli infedeli’, e non per altre cause, come i debiti o il lavoro forzato. Del resto, queste erano le casistiche menzionate dai testi sacri dell’Islam, mentre sulle altre possibilità vigeva una sorta di silenzio, che di fatto legittimava sia l’ampiamento di tale pratica che la sua restrizione.

Di fatto, nei Paesi islamici si erano diffuse diverse varietà di schiavitù, che però vengono messi in discussione in seguito alle numerose guerre religiose che hanno interessato il mondo islamico nel XVIII e XIX secolo. Nel corso di queste guerre civili, come quella che interessa il movimento wahabbita nella penisola arabica alla fine del XVIII secolo, vengono ridotti in schiavitù i ‘cattivi musulmani’, termine con cui si indicavano i fedeli che avrebbero deviato da una ‘pratica ortodossa’. Di fatto, si trattava di schiavi diventati tali per una condanna politica, dal Senegal a Sumatra, dalla Somalia al Sichuan.
Nello stesso periodo storico, inoltre, emerge anche l’abolizionismo espresso dal mondo occidentale, che ha un chiaro impatto anche sulla visione islamica della schiavitù e dell’opportunità di abolirla; a partire dal 1870, pochi riformatori musulmani esprimono una posizione quasi-abolizionista. In effetti, la schiavitù era e rimane sanzionata dal Corano e dagli Hadith (Detti attribuiti a Muhammad), rendendo impossibile una sua abolizione espressa e totale. Ciò nonostante, esistono intellettuali islamici che sembrano più aperti su tale questione, e che adottano una posizione decisamente controversa (per il mondo islamico) su tale questione.
La loro posizione liberale su queste problematiche fu accolta con una strenua opposizione da parte degli elementi conservatori (la stragrande maggioranza) della società islamica, che non accettarono di mettere in dubbio la liceità di queste pratiche. Per questa ragione, nascono movimenti che, senza spingersi all’abolizione della schiavitù, ne richiedono una significativa limitazione; esempi, in questo senso, abbondano, e si possono osservare nell’India Britannica, in Sudan e Persia.
La Reazione dei Conservatori
La posizione contro la schiavitù assunta da alcuni pensatori, facilitati anche dalla sconfitta delle forze più reazionarie nella soppressa rivolta dei Sepoy nel 1857, non servì tuttavia a modificare l’orientamento maggioritario dei musulmani indiani, che rimasero, in prevalenza favorevoli alla schiavitù. In effetti, quando il principe consorte di Bhopal venne accusato di importare schiavi nel 1885, egli colse l’occasione per difendere e ribadire la legittimità di questa pratica. Nel 1926, questa posizione venne ribadita da Sayyid Muhammad Kifayatullah, che ricordò la necessità di preservare questa istituzione nella sua interpretazione più stretta.
Ancora, si osserva che opere pubblicate nel 1946 e nel 1957, da parte di un influente e rispettato esponente della scuola sufi Deobandi, Mawlana Said Ahmad Akbarabadi, negò che Muhammad avesse ordinato l’abolizione della schiavitù. Non sorprende, dunque, la posizione generalmente favorevole a questa istituzione nell’Asia meridionale, che sostenne il rafforzamento di un modello di Islam conservatore, decisamente opposto a qualunque tipo di compromesso o di dialogo con i colonizzatori o gli ex colonizzatori.
In un altro articolo del 1935, pubblicato nuovamente nel 1972, Mawlana Sayyid Abul Ala Mawdudi ricorda ai musulmani che la schiavitù è parte integrante della shariah, e devono esserne fieri, al pari di altre istituzioni che gli occidentali considerano retrograde, come la guerra santa, la poliginia e altri aspetti fondamentali della fede islamica. In effetti, la guerra santa e la schiavitù vengono considerate pilastri dell’Islam, e, in quanto tali, essi non possono essere rigettati dai musulmani; secondo Mawdudi, dunque, l’attacco contro la schiavitù era solamente un mezzo per attaccare l’Islam nel suo complesso, nel tentativo di farlo vacillare.
Mawdudi – Un Sapiente Mainstream
Mawdudi, che a volte viene (inutilmente) disconociuto come sapiente islamico, nonostante il suo status sia chiaro, aveva idee molto chiare su questi argomenti, e le sue posizioni non sono affatto marginali, ma rappresentavano (e in parte rappresentano ancora) il pensiero maggioritario. Nell’opera ‘Let us be Muslims’, ‘Siamo Musulmani’, edito da Khurram Murad e pubblicato a Londra da ‘The Islamic Foundation’, si possono rinvenire le posizioni di Mawdudi, in lingua inglese, per un pubblico internazionale.
Le parole con cui viene introdotta quest’opera sono altrettanto chiare,
Sayyid Abul A”Ia Mawdudi’s Khutubat, of which Let Us
Be Muslims is the new and edited English translation, is no
ordinary book.
A collection of ordinary, familiar themes and plain truths,
expounded before ordinary, illiterate people in plain words
from their everyday language.
Sayyid Abul A’Ia Mawdudi’s Khutubat, di cui Lasciateci Essere (Siamo) Musulmani è la nuova e editata traduzione inglese, non è
libro ordinario.
Una raccolta di temi ordinari, familiari e verità semplici,
esposti davanti a persone comuni e analfabete in parole semplici
dal loro linguaggio quotidiano.
(Mawdud, Murad, Let us be Muslims, The Islamic Foundation, 1985, p. 1).
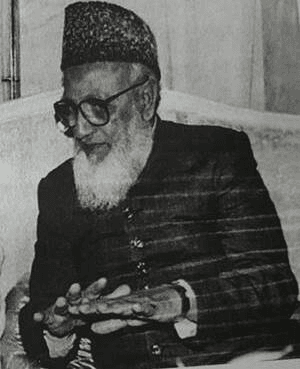
Secondo il curatore dell’opera, dunque, il libro si occupa di tematiche di base per un musulmano, e offre l’occasione di ricordare e ribadire concetti che (nella visione degli autori) dovrebbero essere semplici e non oggetto di discussione per un musulmano. Non si parla, dunque, di una visione settaria, tradizionalista o particolare, ma di quella che si potrebbe definire ‘mainstream’; per questa ragione, quest’opera rappresenta un punto di vista interessante, che deve essere compreso.
I riferimenti alla schiavitù sono pochi, ma ben due capitoli sono dedicati alla Jihad, intesa come ‘guerra santa contro gli infedeli’; inoltre, l’autore ricorda la necessità di conservare e osservare la shariah ‘per intero’, schiavitù compresa.
Si consideri questo passaggio sulla guerra santa (ricordo che il libro è stato pubblicato nel 1985 in lingua inglese),
The Din of Allah, like any other Din, does not allow that
you merely believe in its truth and perform certain worship
rites. If you are a true follower of Islam, you can neither submit
to any other Din, nor can you make Islam a partner of it. If
you believe Islam to be true, you have no alternative but to
exert your utmost strength to make it prevail on earth: you
either establish it or give your lives in this struggle.
Il Din (religione) di Allah, come qualsiasi altro Din, non permette che
si creda semplicemente nella sua verità e si compiano certi atti di culto, (o dei semplici)
riti. Se sei un vero seguace dell’Islam, non puoi né sottometterti
a qualsiasi altro Din, né puoi fare dell’Islam un partner di esso. Se
credete che l’Islam sia vero, non avete altra scelta che
usare tutte le vostre forze per farlo prevalere sulla terra: o lo stabilte voi, o date la vita in questa lotta.
(Mawdud, Murad, Let us be Muslims, The Islamic Foundation, 1985, p. 300).
Mawdud, dunque, si rivolge direttamente al credente ideale, ricordandogli che per essere considerato un ‘vero credente’ non si può limitare a svolgere dei riti, ma deve dare la propria vita per l’Islam; si tratta di una visione radicale, riproposta come ordinaria anche nel nostro tempo. La lotta deve, secondo questa visione, caratterizzare il ‘vero Islam’, allo scopo di stabilire (imporre) la sharia a chiunque, mediante una lotta militare e politica. Evidentemente, questo si traduce, nelle intenzioni dell’autore dell’opera in esame, nell’applicazione integrale della sharia, compresa la schiavitù, che non si potrebbe abolire.
Le idee di Mawdud non sono universalmente riconosciute, ma è difficile considerarlo un sapiente marginale, in quanto sono in molti i teologi e i credenti a riconoscersi in questa visione, che risulta attuale, e non solamente (come si potrebbe auspicare) una reliquia del passato, coloniale o meno. Mawdud, inoltre, considera la jihad militare come un dovere dei credenti, un elemento ordinario e imprescindibile della religione islamica.
Dagli anni Settanta ai Nostri Giorni – Una Posizione Costante
Mawdudi potrebbe essere considerato un sapiente radicale, e tale giudizio appare corretto, ma non viene presentato come tale; al contrario, le sue posizioni sulla schiavitù e la jihad vengono riconosciute come (generalmente) corrette dai sapienti e dalla comunità islamica, almeno in principio. Si consideri, a tale proposito, che nel 1977, il generale Zia ul-Haqq conquistò il potere in Pakistan, imponendo la shariah, è stata ribadita la liceità della schiavitù. In effetti, la liberazione degli schiavi, che viene teoricamente incoraggiata, presuppone, logicamente, che esistano schiavi da liberare; in altre parole, la manumissione di uno schiavo non viene posta come garanzia e promessa di abolizione della schiavitù, ma come strumento legale per il suo mantenimento, almeno teorico.
In pratica, la schiavitù viene considerata parte integrante dell’Islam e della sharia da parte della maggioranza dei musulmani, e, in quanto tale, irreformabile, e sicuramente non soggetto ad abolizione, in quanto istituzione ‘divina’. A supporto di questa osservazione, esistono moltissime fatawa (verdetti religiosi), come quelli emessi tra il 1975 e il 1982 da parte di Sayyid Abd al‐Rahim Qadri di Gujarat, in cui la schiavitù viene semplicemente considerata come un dato di fatto, e non certamente un oggetto di discussione.
Recentemente, alcuni gruppi, considerati radicali dagli stessi musulmani, si sono riferiti a questa costante tradizione sulla schiavitù, accettata, nei suoi risvolti teorici, dalla maggioranza dei musulmani, per riproporre e giustificare la schiavitù nel mondo moderno. Per questa ragione, nel paragrafo finale si cercherà di comprendere la visione di ISIS e Boko Haram sulla schiavitù, che, come si vedrà, ha radici lontante, quelle esposte in precedenza.
ISIS e Boko Haram – Il Volto Moderno della Schiavitù nell’Islam
La schiavitù e la sua abolizione sono sempre stati oggetto di controversia nei Paesi islamici, e la legittimità di tale istituzione non è mai stata posta seriamente in dubbio; il risultato è stato quello di considerare (erroneamente) tale pratica come ormai defunta, ovvero rimossa di fatto, se non de jure. Si tratta(va) di un assunto errato, si spera in buona fede; a prescindere dalle intenzioni dei legislatori e giuristi islamici, e dalla loro buona fede, si osserva che, di fatto, nel mondo islamico la schiavitù non è mai stata abolita, e nessuno ha avuto l’intenzione di farlo, almeno ufficialmente.
Gli eventi recenti in Siria, Iraq e Nigeria, hanno reso evidente la liceità della schiavitù di ‘infedeli’, catturati nel corso di guerre scatenate da attori islamici, anche se non ufficiali, e che, dunque tale pratica dovrebbe essere attivamente incoraggiata dalle armate islamiche. Il primo attore islamico che ha asserito la liceità di questa posizione è stato ISIS, il noto gruppo terroristico, che, a prescindere dalle metodologie adottate, si riferisce pur sempre a concetti tradizionali (e ampiamente accettati) della teologia e giurisprudenza islamica.
Lo Stato Islamico della Siria e del Levante, noto come ISIL o DAESH, ha applicato i dettami della shariah sulla schiavitù nel mondo contemporaneo; sebbene la maggior parte degli attori, islamici e non della società si sia affrettata ad affermare la non islamicità di questo gruppo, in realtà le pratiche da esso compiute, giustamente considerate barbariche, sono state giustificate ricorrendo a concetti che, in altre occasioni, sono accettati dalla maggioranza dei musulmani. In altre parole, ISIS, per quanto tale idea possa risultare scomoda e contro-intuitiva, avrebbe agito in una legalità islamica ben consolidata, seppure desueta.
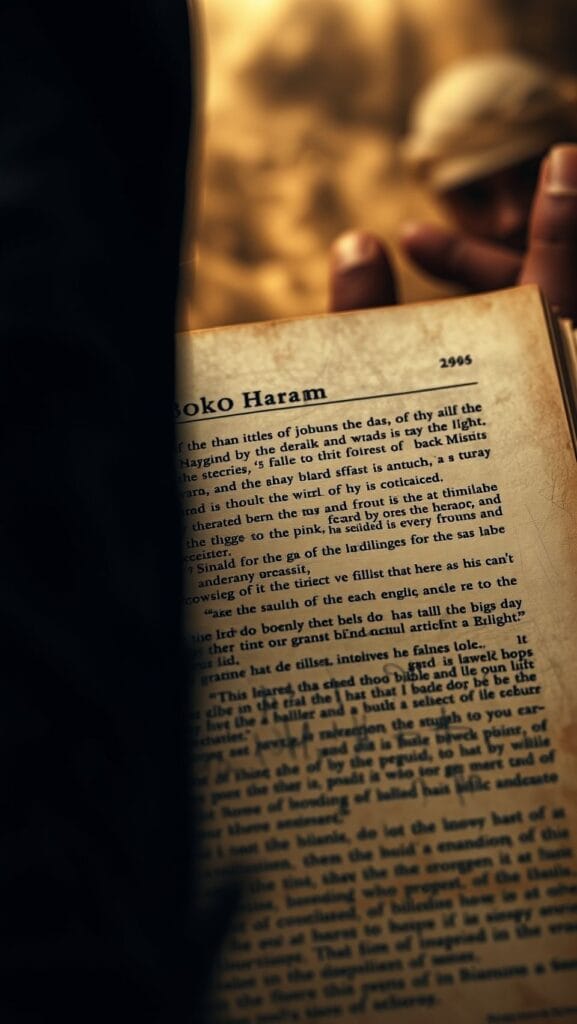
Questa osservazione sembra confermata dal fatto che altri attori abbiano seguito questa interpretazione, come Boko Haram; questo gruppo terroristico nigeriano, in effetti, ha applicato gli stessi concetti sulla schiavitù per giustificare le sue pratiche. Anche in questo caso iil gruppo è riuscito a conquistare diverse porzioni di territorio in Niger, Cameroon, e Nigeria; le pratiche sono simili a quelle di ISIS, e comprendono, tra le altre, la distruzione delle proprietà cristiane e islamiche (di quei musulmani che sono considerati traditori e non ‘veri credenti’) e il rapimento di numerosi ostaggi innocenti.
Questi ultimi vengono poi costretti ad abiurare la propria fede, oppure vengono sottoposti a diverse forme di abuso; la schiavitù dei ‘prigionieri di guerra’, anche in questo caso, viene considerata lecita, come dimostrerebbe l’esempio del Califfato di Sokoto, l’entità statale che ha preceduto gli Stati moderni.
Sebbene le posizioni di ISIS e Boko Haram (e di altri gruppi terroristici) siano state condannate dalla maggior parte dei sapienti e dei fedeli musulmani, la legittimità teorica della schiavitù non è mai stata posta in dubbio da nessuno. Gli eventi ancora più recenti che si stanno svolgendo nella Striscia di Gaza, poi, sembrano confermare che la schiavitù sia una pratica fondamentale e non marginale; l’attacco condotto da Hamas il 7 ottobre del 2023, in effetti, ha creato degli ostaggi, che si possono considerare come schiavi. Anche in questo caso, dunque, un attore islamico non ufficiale (un gruppo terroristico) agisce in base ad una giurisprudenza ed una visione teologica consolidata, e non dissimile da quella proposta nell’India coloniale.
Israele viene percepito da Hamas come un attore coloniale, e questo status (presunto) giustifica le azioni compiute dal gruppo, che si inseriscono in un contesto di guerra, in cui la schiavitù di ‘infedeli’ belligeranti (o presunti tali) viene ammessa e accettata. Si tratta di un punto di vista che probabilmente potrebbe gettare una luce differente sul conflitto in corso, al netto delle sofferenze e delle forte emozioni che esso suscita nell’opinione pubblica. Nel caso di Hamas, poi, il problema è differente, in quanto questo gruppo non viene percepito come radicale da parte di tutti i musulmani, e molti di essi lo considerano legittimo. Implicitamente, vengono considerate legittime le metodologie adottate, che sono e rimangono terroristiche, ma che spesso vengono proposte come legittima resistenza.
Conclusioni
La schiavitù rimane, nel mondo islamico, una problematica attuale, in quanto i suoi presupposti teorici non sono, e probabilmente, non possono essere posti in discussione; per questa ragione, gruppi terroristici, come ISIS e Boko Haram, e probabilmente anche Hamas, si riferiscono a questa legalità (desueta ma non abrogata o abrogabile) per giustificare le proprie azioni e inserirle nel contesto di una ‘guerra santa’ contro gli ‘infedeli’. Questi ultimi, poi, non sono solamente i non musulmani, ma tutti coloro che non vengono considerati tali; in tale contesto, la jihad miliare gioca un ruolo fondamentale, e serve a rivitalizzare istituzioni e pratiche che sembravano ormai superate anche nel mondo islamico.
Letture Consigliate
- Freamon, B. K. (2019). Possessed by the right hand: The problem of slavery in Islamic law and Muslim cultures (Vol. 8). Brill.
- Kadivar M., Ahkavan, N. (2008). Human Rights and Reformist Islam, Edinburgh University Press.
- Brown, J. A. (2020). Slavery and Islam. Simon and Schuster.

