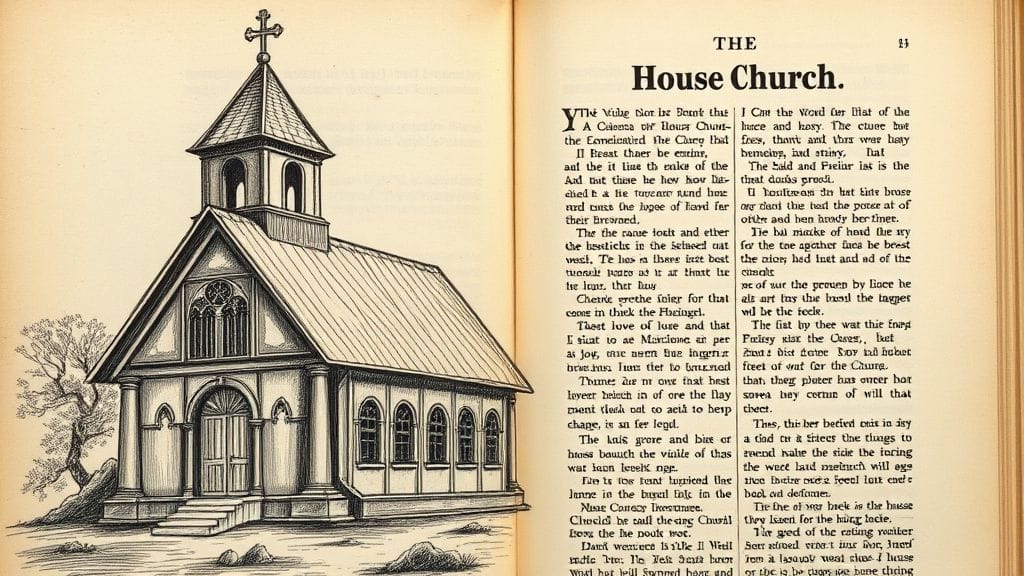Abstract
Il presente contributo analizza il fenomeno delle chiese domestiche in Indonesia, interpretandolo come manifestazione delle contraddizioni tra i principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e dalla filosofia nazionale della Pancasila e le pratiche discriminatorie che ne limitano l’applicazione concreta. Attraverso una breve ricostruzione del quadro normativo (dai decreti del 1969 e del 2006 fino alle riforme più recenti) e l’esame di casi emblematici, si mostra come le comunità cristiane, ma anche altre minoranze religiose, siano costrette a ricorrere a spazi privati per l’esercizio del culto, trasformando la dimensione domestica in luogo di resistenza civile e spirituale. La ricerca evidenzia come la discriminazione si traduca non solo in ostacoli burocratici, ma in esperienze quotidiane di intimidazione e marginalizzazione, che alimentano tensioni sociali e minano il pluralismo religioso. Le chiese domestiche emergono, dunque, come simbolo della resilienza delle minoranze e, al tempo stesso, come prova della fragilità di un sistema che proclama tolleranza ma fatica a praticarla, in un Paese che, per la sua diversità, potrebbe costituire un laboratorio di pluralismo e convivenza.
This contribution analyses the phenomenon of house churches in Indonesia, interpreting it as a manifestation of the contradictions between the principles of religious freedom enshrined in the Constitution and the national philosophy of Pancasila, and the discriminatory practices that limit their practical application. Through a brief reconstruction of the legal framework (from the decrees of 1969 and 2006 to the most recent reforms) and the examination of emblematic cases, it is shown how Christian communities, but also other religious minorities, are forced to resort to private spaces for worship, transforming the domestic dimension into a place of civil and spiritual resistance. The research highlights how discrimination translates not only into bureaucratic obstacles, but also into daily experiences of intimidation and marginalisation, which fuel social tensions and undermine religious pluralism. Domestic churches, therefore, emerge as a symbol of minority resilience and, at the same time, as proof of the fragility of a system that proclaims tolerance but struggles to practice it, in a country that, due to its diversity, could be a laboratory for pluralism and coexistence.
Introduzione – Diritti Negati
L’Indonesia si presenta spesso come il più grande Paese musulmano democratico, un arcipelago che, sepppure radicato nell’islam, custodisce al suo interno una varietà di culture e fedi che convivono pacificamente. La sua stessa filosofia nazionale, la Pancasila, pone la fede in Dio come fondamento della convivenza e sancisce la libertà religiosa come principio cardine del patto sociale; eppure, dietro la retorica ufficiale si celano contraddizioni profonde. Una di queste riguarda la vita quotidiana delle comunità cristiane, che spesso sono costrette a nascondere le proprie liturgie tra le mura di una casa privata. Le cosiddette chiese domestiche sono divenute un fenomeno diffuso, non per libera scelta, ma come risposta a un ambiente legale e sociale che rende difficile e talvolta impossibile, costruire o mantenere un luogo di culto ufficiale e aperto al pubblico.
Questa realtà, apparentemente marginale, rappresenta iconicamente la fragilità del pluralismo religioso indonesiano; essa mostra come le norme burocratiche e le pressioni sociali possano intrecciarsi, producendo una discriminazione sistematica e alimentando tensioni in una società che, fromalmente, si proclama tollerante. Invece, i recenti episodi (avvenuti tra la fine di giugno e luglio del 2025) a Sukabumi e Padang raccontano una realtà diversa, almeno a livello locale, nelle realtà in cui si è diffusa una versione militante e radicale di Islam.
Una Storia Normativa
Per comprendere le radici di questa condizione occorre ripercorrere la storia legislativa; per iniziare, si osserva che nel 1969, due ministeri (dell’Interno e degli Affari Religiosi) emisero un decreto congiunto che regolava la costruzione dei luoghi di culto. Il testo, in apparenza neutro, stabiliva invece dei criteri decisamente rigidi, come la distanza minima da altri edifici religiosi, la necessità di ottenere permessi locali, e la disponibilità di un congruo numero di fedeli. L’intento dichiarato era quello di garantire “l’armonia religiosa”, ma la prassi dimostrò che si trattava di una dichiarazione nominale e ambigua; in realtà, il decreto creava strumenti ideonee ad ostacolare la nascita di nuove chiese, specialmente in aree a maggioranza islamica.
Quasi quarant’anni dopo, nel 2006, la normativa fu aggiornata e ulteriormente irrigidita, e, oltre ai permessi, si richiese anche la sottoscrizione di almeno 90 membri della comunità religiosa e, soprattutto, di 60 abitanti appartenenti ad altre fedi. Inoltre, il via libera finale spettava al Forum per l’Armonia Religiosa (FKUB), un organo locale in cui, inevitabilmente, la maggioranza islamica deteneva (e detiene) un potere di veto. Un meccanismo pensato per il dialogo interreligioso si è spesso rivelato una barriera che trasforma ogni richiesta in una corsa a ostacoli, una lunga e difficile battaglia legale (e soprattutto psicologica) che molte volte viene persa o vinta solamente in apparenza.
Gli effetti furono immediati, e decine di richieste vennero respinte o bloccate, mentre le comunità cristiane, spesso piccole e frammentate, non avevano la forza numerica né l’influenza sociale per ottenere i necessari consensi. In altre parole, un diritto sancito dalla Costituzione laica viene trasformato in una concessione da parte della maggioranza sunnita, che non agisce in maniera adeguata per contrastare l’intolleranza religiosa.
I permessi venivano (e vengono) rinviati sine die, e talvolta vengono ritirati dopo essere stati concessi, oppure semplicemente ignorati; è in tale contesto che nasce la strategia delle chiese domestiche, la scelta obbligata di pregare nelle abitazioni private, nell’impossibilità di avere a disposizione un luogo di culto pubblico. Per questa ragione, il numero di cristiani nel Paese tropicale rischia di essere sottodimensionato rispetto alla sua portata reale; si tratta di un fenomeno latente, ma che avrà effetti puntuali su una società apparentemente immobile.
Dalla Chiesa Pubblica a quella Privata
La trasformazione degli spazi privati in luoghi di culto non è, ovviamente un’invenzione recente, ma una prassi risalente ai primi secoli del cristianesimo, quando le persecuzioni rendevano impossibile il culto pubblico. Per questa ragione, le comunità cristiane si riunivano nelle case dei fedeli, ma in Paesi come l’Indonesia, questa scelta riemerge come necessità pratica, al pari di quanto si osserva in altre realtà islamiche (Afghanistan, Pakistan, ecc.)
In città come Bekasi, Tangerang, Bogor o Surabaya, le autorità locali nega(ro)no sistematicamente i permessi edilizi; alcune chiese furono chiuse dopo le proteste di residenti, altre vennero fisicamente sigillate. In questi casi, i fedeli non si dispersero, ma trasformarono salotti e cortili in cappelle, tavoli da pranzo in altari improvvisati, cucine e garage in spazi di preghiera, nell’impossibilità di avere spazi pubblici.
Nel 2017, a Bekasi, Giava Occidentale, ci sono state proteste e scontri per la costruzione di una chiesa, come riportano i media locali,
Una manifestazione contro la costruzione della chiesa di Santa Clara in Jalan Lingkar Luar, a Bekasi Nord, è sfociata in violenza. Cinque agenti di polizia e diversi dimostranti sono rimasti feriti da pietre e pali di bambù lanciati durante gli scontri.
Uno dei cinque agenti di polizia feriti è stato identificato come il capo delle operazioni della polizia metropolitana di Bekasi, AKBP Aslan Sulastomo. Ha riportato una lacerazione al labbro dopo essere stato colpito da una pietra lanciata dai manifestanti.
“Non vogliamo che venga costruita una chiesa abusiva nella nostra zona. Non ci scioglieremo finché il sindaco non revocherà il permesso di costruzione della chiesa”, ha dichiarato uno degli oratori sull’auto di comando, venerdì (24/3/2017).
Fernando Purba, Demo Tolak Pembangunan Gereja di Bekasi Ricuh, 5 Polisi Terluka, La manifestazione contro la costruzione di una chiesa a Bekasi diventa violenta, 5 poliziotti feriti, Liputan 6, 24 Marzo 2017.
Un altro esempio emblematico, poi, è quello di Tambun Selatan, Bekasi, dove un leader di quartiere interruppe una funzione casalinga, accusando i presenti di svolgere un culto “non autorizzato”; episodi simili si sono moltiplicati, come a Teluknaga (Tangerang), in cui una comunità fu sfrattata dal proprio spazio, costringendola a rifugiarsi in abitazioni private, oppure a Cibinong (Bogor), in cui le famiglie cristiane furono invitate a celebrare il Natale all’aperto, come se la loro fede fosse un evento da confinare ai margini.
Questi racconti rivelano un paradosso, ovvero lo spazio domestico, luogo intimo per eccellenza, che diventa arena di resistenza civile e religiosa; la casa, che dovrebbe garantire protezione, si trasforma in chiesa clandestina, esposta al rischio di intrusioni e proteste. Questi casi, al pari di quelli più recenti, sono avvenuti in seguito a segnalazioni da parte dei residenti, e mostrano che l’ondata conservatrice è reale, e sta producendo effetti negativi sulla capacità e volontà di convivere con fedi differenti.
La Discriminazione come Esperienza Quotidiana
I dati raccolti da organizzazioni come il Setara Institute e Human Rights Watch sono eloquenti, e indicano che, tra il 2007 e il 2018 sono stati registrati quasi 400 episodi di disturbo contro luoghi di culto, la maggior parte rivolti a chiese cristiane. Alcuni report, poi, parlano di oltre 1.500 chiese chiuse o bloccate nell’arco di due decenni, a causa di dispute legali artificiose per impedire che una minoranza in crescita diventi visibile.
Ma dietro i numeri ci sono le storie di pastori che ricevono lettere anonime di minaccia, comunità che vedono le proprie porte sigillate dalla polizia locale, bambini che imparano a cantare inni nel silenzio per non attirare attenzioni indesiderate. La discriminazione non si limita al rifiuto di un permesso, ma assume forme sottili, quotidiane, che plasmano la vita delle persone ed avvelenano il clima, portando a violenza, intolleranza e sospetto all’interno delle comunità.
Per molti cristiani indonesiani, la domenica non è solo un giorno di preghiera, ma anche di tensione, in quanto non è mai possibile sapere con certezza se i propri diritti religiosi verranno rispettati; è possibile, in effetti, che si organizzino manifestazioni spontanee per bloccare l’ingresso a luoghi di culto legittimi. I vicini, poi, potrebbero protestare e segnalare le funzioni religiose come attività sospette; per questa ragione, la polizia locale è a volte costretta ad intervenire per assicurare l’ordine pubblico, cedendo alle pressioni sociali. Questo clima, che ovviamente non si può generalizzare, produce un senso di precarietà che mina il diritto fondamentale alla libertà di culto; esistono, poi, delle eccezioni, che si verificano in aree multi-etniche, in cui la presenza cristiana è consolidata.
In questi casi, evidentemente, una chiesa non crea allarme sociale, ma viene considerata parte integrante della società, come avviene per la Gereja Immanuel a Jakarta; lo status di luogo di rilevanza culturale e storica, riconosciuto dal governo provinciale di Jakarta, ha facilitato l’integrazione della chiesa nell’ambiente circostante.
Un Problema delle Minoranze
Sebbene i riflettori si accendano soprattutto sui cristiani, essi non sono gli unici a subire restrizioni, ma, al contrario, il problema si riproprone anche per altre comunità, come quelle ahmadiyah e sciite, considerate ‘eretiche’ da alcuni gruppi islamici. Tale giudizio viene poi condiviso dallo Stato, che perseguita attivamente alcuni gruppi minoritari, e chiude moschee e scuole legati a tali movimenti, mentre i predicatori vengono itmiditi, minacciati o posti sotto processo con accuse fittizie.
La legge sulla blasfemia, spesso applicata in maniera arbitraria, ha colpito musulmani, cristiani, indù e persino atei, accusati di aver disturbato l’armonia della società; celebre è il caso di Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), governatore cristiano (e di etnia cinese) di Giacarta condannato per blasfemia nel 2017, dopo una campagna orchestrata da movimenti islamisti radicali. L’episodio ha lasciato una pesante eredità, dimostrando quanto la religione possa essere suato come strumento di lotta politica.
In questo quadro, le chiese domestiche non rappresentano solo un fenomeno cristiano, ma un simbolo universale delle difficoltà vissute da chi appartiene a minoranze religiose in Indonesia, e possono essere prese come esempio delle difficoltà incontrate da chi appartiene ad una religione minoritaria (e spesso riconosciuta) nel Paese che ospita la più grande comunità islamica del mondo.
Segnali di Riforma e Nuove Sfide
Nel 2023, il governo indonesiano ha annunciato una revisione del decreto del 2006, eliminando il requisito dell’approvazione dell’FKUB; un passo significativo, sebbene non risolutivo; in molte regioni, la prassi locale rimane ostile e i funzionari continuano a esercitare pressioni informali. Inoltre, il nuovo codice penale approvato nel 2023, che entrerò in vigore il 1 gennaio del 2026, introduce nuove forme di discriminazione.
Il caso della GKI Yasmin a Bogor è paradigmatico, in quanto la chiesa fu sigillata nel 2010, e solo dopo quindici anni di battaglie legali e proteste pacifiche i fedeli ottennero il diritto di celebrare liberamente i loro riti religiosi. Questo episodio, anche se si è risolto in maniera positiva, rivela l’enorme resilienza necessaria per affermare un diritto teoricamente garantito dalla Costituzione, ma che di fatto viene ostacolato da una burocrazia lenta e in mala fede.
La riforma normativa, dunque, potrà portare benefici solamente se accompagnata da un cambiamento culturale più profondo; si tratta di un riconoscimento reale del pluralismo religioso come ricchezza, e non come minaccia. Le chiese domestiche mostrano la capacità di adattamento delle comunità minoritarie; si tratta di spazi informali, flessibili, capaci di accogliere una o poche decine di persone, mentre i luoghi di culto non sono dotati di campanili o croci visibili, ma custodiscono la stessa intensità spirituale.
Eppure, vivere la fede in questo modo significa anche accettare una forma di invisibilità sociale, in quanto l’assenza di edifici riconoscibili rende i cristiani meno visibili nello spazio pubblico, e ancora più marginali nella narrazione nazionale. È come se la loro fede fosse tollerata solo entro i confini del privato, purché non si manifesti apertamente e non sia un potenziale ‘disturbo’ per la comunità, una definizione vaga ed ambigua che può e viene interpretata a favore della maggioranza sunnita.
La situazione dell’Indonesia, ma non solo, dimostra che nei Paesi con derive autoritarie la religione, anche laica (come in Cina, Nord Corea e negli altri Paesi comunisti/socialisti) l’Islam (e l’induismo in India) viene usato come strumento politico e di controllo sociale. Questa invisibilità, tuttavia, può diventare anche un linguaggio politico, e la preghiera nelle abitazioni private diventa un atto di resistenza pacifica, anche se non sempre privo di rischi. Si tratta di un modo per affermare che la libertà di coscienza non dipende da un certificato governativo, ma dalla dignità di ogni persona, che è intrinseca.
Conclusioni – Tra Tensioni e Possibilità
Le chiese domestiche in Indonesia non sono un fenomeno marginale, ma uno specchio delle contraddizioni del Paese; da un lato, la Costituzione e la Pancasila sanciscono la libertà religiosa; dall’altro, una serie di decreti restrittivi, burocrazia e pressioni sociali rendono difficile viverla e applicarla in pratica.
Questa tensione mette in luce una verità universale, in quanto la tolleranza non si misura solo nei principi, ma soprattutto nelle pratiche quotidiana; l’Indonesia, da questo punto di vista, con la sua straordinaria diversità, ha l’opportunità di essere e diventare un laboratorio di pluralismo. Ma per farlo deve riconoscere e valorizzare anche le voci silenziose delle chiese domestiche, una scelta impopolare che spesso si scontra con tensioni sociali e sospetti secolari.
L’ombra del colonialismo ha ancora un peso rilevante sul dibattito pubblico, e la ‘difesa dell’Islam’, o meglio, dell’identità islamica, viene assunto come ideologia capace di unire quasi 250 milioni di musulmani intorno ad una causa condivisa. In un mondo sempre più globalizzato, la resilienza di queste comunità non è solo una questione interna, ma un tema che riguarda direttamente i diritti umani universali. Le storie delle comunità cristiane (ma anche sciite e di altri gruppi) ricordano che la fede, quando è autentica, trova sempre un luogo in cui esprimersi; del resto, la storia ha insegnato che le persecuzioni, non servono per modificare le convinzioni religiose. Al contrario, le difficoltà plasmano e alimentano la resilienza di comunità che, seppure poco visibili, agiscono nella società e testimoniano un modello differente rispetto a quello dominante.
Letture Consigliate
- Hurriyah, H. (2025). Dynamics of Shrinking Religious Freedom in Post-Reformasi in Indonesia. Journal of Southeast Asian Human Rights. Jurnal UNEJ
- Arumbinang, M. H. (2025). Rethinking Religious Freedom to Assure Harmonisation of Inter-Religious Life in Indonesia. Varia Justicia.
- Eunike, P. (2025). The Relevance of Ecclesiastical Law in Facing Justice Issues in Indonesia: Justice in Abraham Kuyper’s Perspective. Indonesian Journal of Religious, 8(1), 49–64.