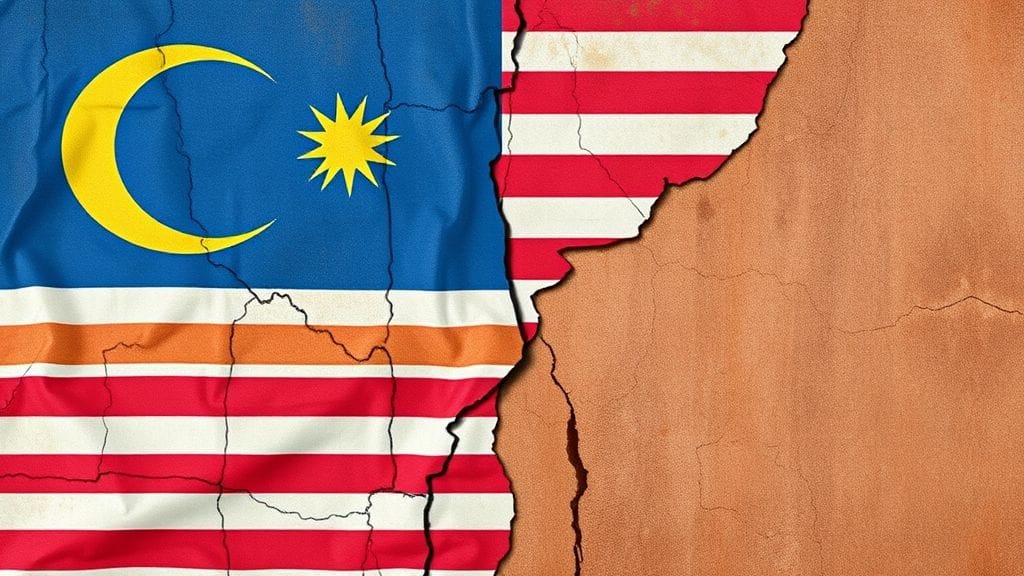- Abstract
- Introduzione – Un Fronte Composito
- Musulmani Liberali – Fede e Critica
- Socialisti e Anarchici – Il Filo Rosso dell’Uguaglianza
- Cristiani, Indù e la Difficile Libertà Religiosa
- Le Voci Indigene
- Conclusione
- Letture Consigliate
Abstract
La Malesia è un Paese che si presenta come un mosaico composito di culture e religioni in cui il dissenso rispetto al modello islamista imposto dalla maggioranza sunnita viene considerato una minaccia per la società. Il mito narrativo di un popolo stretto intorno al re, garante e difensore dell’Islam, non regge all’analisi delle dinamiche sociali e politiche contemporanee; le minoranze religiose, politiche e etniche, marginalizzate ed escluse dalla vita pubblica, continuano a rivendicare il rispetto dei loro diritti e del loro diritto ad esistere. La Costituzione, che teoricamente prevede una società plurale deve dunque essere interpretata non solamente a favore della maggioranza sunnita, ma per favorire lo sviluppo di una società plurale.
Malaysia is a country that presents itself as a composite mosaic of cultures and religions where dissent against the Islamist model imposed by the Sunni majority is considered a threat to society. The narrative myth of a people united around the king, the guarantor and defender of Islam, does not hold up to an analysis of contemporary social and political dynamics; Religious, political, and ethnic minorities, marginalised and excluded from public life, continue to demand respect for their rights and their right to exist. The Constitution, which theoretically provides for a pluralistic society, must therefore be interpreted not only in favour of the Sunni majority, but also to promote the development of a pluralistic society.
Introduzione – Un Fronte Composito
La Malesia appare, ad un primo sguardo, come una nazione che ha saputo armonizzare la sua composizione multietnica e multireligiosa; nel Paese asiatico, in effetti, convivono Malay, cinesi, indiani e comunità indigene. Tali persone vivono entro i confini di uno Stato che proclama l’unità nella diversità, al pari dell’Indonesia; invece, dietro questa immagine ufficiale, la società malese è attraversata da tensioni profonde, legate alla centralità accordata all’Islam e alla comunità malese. La sharia, pur non essendo l’unico sistema giuridico, ha progressivamente ampliato la propria sfera d’influenza, condizionando la vita civile e alimentando un senso di esclusione in quanti non appartengono alla maggioranza sunnita.
In effetti, esiste una retorica, sia governativa che religiosa, incentrata intorno al tema dell’unità e dell’obbedienza al re, garante e difensore dell’Islam; in Malesia, molti sermoni religiosi sono disponibili online, e molti di essi ruotano attorno a questo tema, e non solamente in occasione di eventi quali l’incoronazione o l’anniversario del sovrano.
Hubungan antara rakyat dan Raja dalam Islam diikat dengan rasa hormat, taat, dan doa
antara satu sama lain. Rakyat perlu menumpahkan taat setia kepada Raja dan negara
sesuai dengan lafaz ikrar Rukun Negara. Kesetiaan kepada Raja bukan sekadar budaya,
tetapi tuntutan agama sepertimana yang dinyatakan melalui firman Allah SWT (…)
Il rapporto tra il popolo e il re nell’Islam è vincolato dal rispetto reciproco, dall’obbedienza e dalla preghiera. Il popolo deve giurare fedeltà al Re e al Paese in conformità con il giuramento Rukun Negara. La lealtà al Re non è semplicemente una cultura, ma un requisito religioso (evidentemente anche per cristiani, indù, buddisti e altre minoranze religiose, ndr), come affermato nella parola di Allah (…)
E-Khutba, Dirgahayu Tuanku: Raja Dikasihi, Negara Diberkati, Lunga vita a Vostra Maestà: Re Amato, Paese Benedetto, 30 Maggio 2025.
In questo sermone, recente, si nota il collegamento esplicito tra Stato e Islam, in cui l’obbedienza al Re, rappresentante della religione maggioritaria, viene considerata (e proposta) come garanzia del benessere e della prosperità nazionale.
L’immagine che si vuole trasmettere è dunque quella di un Paese coeso intorno al suo sovrano, obbediente ai suoi comandi; si tratta, evidentemente, di una narrativa che non regge il confronto con la realtà, decisamente più eterogenea e complessa rispetto alla retorica ufficiale.
In tale contesto, i fronti del dissenso si presentano frammentati, eterogenei, ma accomunati dal rifiuto di una logica che intreccia religione, etnia e potere politico in maniera esplicita, e anche grossolana; un discorso si questo genere si poteva rinvenire, forse, in ambito cristiano nel XIX e inizio del XX secolo. In Malesia, tuttavia, questo genere di argomentazioni è ancora vivo e dinamico; in Indonesia, invece, questi toni si possono rinvenire nei leader islamisti e populisti, come Ismail Susanto, il leader del disciolto Hizbut Tahrir Indonesia.

Alcuni contestano l’impostazione populsita e islamista dall’interno, mentre altre voci critiche si pongono all’esterno dell’Islam; i musulmani liberali, in effetti, propongono un modello di Islam differente da quello ‘mainstream’. I socialisti, invece (che possono anche essere musulmani del resto) rivendicano l’uguaglianza sociale, cristiani, buddisti e indù difendono la libertà religiosa, mentre le comunità indigene reclamano dignità e autonomia. Si tratta di voci minoritarie, spesso represse o marginalizzate, ma che, nel loro insieme, propongono una narrativa differente rispetto alla narrazione dominante, che ha assunto tratti decisamente populisti e islamisti.
Musulmani Liberali – Fede e Critica
Come anticipiato in precedenza, tra le voci dissenzienti rispetto alla propaganda del regime malese si trova quella dei musulmani liberali, che assume un valore particolare, in quanto nasce dentro la stessa comunità che detiene il primato politico e culturale. Non si tratta di un rifiuto della religione, come invece ritiene la maggioranza conservatrice, ma di un tentativo di liberarla dalla sua riduzione a strumento di controllo sociale.
Si inserisce in tale contesto il movimento noto come ‘Sisters in Islam‘, SIS, fondato da donne musulmane istruite e cosmopolite, che ha assunto un ruolo simbolico in questa direzione; le sue esponenti, in effetti, non parlano un linguaggio estraneo alla tradizione. Al contrario, esse rivendicano un’interpretazione coranica più fedele allo spirito originario, capace di valorizzare l’uguaglianza tra i sessi e la dignità della persona. L’accento, in effetti, viene posto sulla denuncia dell’uso strumentale della sharia per giustificare discriminazioni e sottolineano come la religione possa e debba essere letta alla luce della giustizia sociale.
Il modello proposto, dunque, è pienamente compatibile con un moderno Stato di diritto e con i diritti umani, una nozione che nel mondo islamico viene spesso distorta e interpretata in modo non conforme con l’accezione universalmente accettata. Per queste ragioni, la loro voce è minoritaria e spesso accusata di ‘occidentalismo’, eresia o addirittura apostasia; invece, essa rappresenta un segnale importante e dimostra che anche nel mondo malese-musulmano esistono prospettive alternative, che rifiutano l’idea di un islam monolitico e totalizzante. La loro presenza rompe la narrazione secondo cui religione e politica coincidono inevitabilmente, e presenta un modello che invece tende a coincidere con i valori democratici, senza rinunciare all’identità islamica.
Socialisti e Anarchici – Il Filo Rosso dell’Uguaglianza
Un altro fronte, meno visibile ma non meno significativo, è quello della sinistra, e da questo punto di vista, si osserva che la Malesia ha conosciuto, in passato, una forte tradizione socialista; si pensi, in questo senso, al Malayan Communist Party, che guidò la resistenza anticoloniale nella cosiddetta Emergenza (1948-1960). Dopo l’indipendenza, il socialismo venne represso e stigmatizzato come minaccia all’ordine nazionale, al pari di quanto avvenuto in Indonesia; tuttavia, le idee di uguaglianza sociale e di giustizia economica non sono mai scomparse.
Il Partito Socialista della Malesia (PSM) ne è la testimonianza attuale, e, seppure con un peso elettorale marginale, esso lavora quotidianamente nelle periferie urbane, nelle piantagioni e tra i lavoratori migranti; le battaglie simbolo sono quelle per il caro-vita, per il diritto alla casa e per una distribuzione più equa delle risorse. Si tratta, dunque, di una sinistra pragmatica, attenta ai bisogni immediati della popolazione, ma che mantiene una visione alternativa al nazionalismo religioso, e che, come tale, viene stigamtizzata come anti-nazionale.
Oltre al PSM, ma in maniera sotterranea, si muovono gruppi anarchici e libertari, spesso collegati a sottoculture giovanili, al mondo punk, oltre che a reti femministe e ambientaliste; questi gruppi, evidentemente, non hanno una rappresentanza politica ufficiale, ma incarnano un dissenso esistenziale, segnato da pratiche quotidiane di solidarietà, autogestione e rifiuto dell’autoritarismo religioso e politico. Nei loro spazi, sia realei che virtuali, come i concerti clandestini o i centri sociali di Kuala Lumpur e Penang, si respira un’aria che rifiuta tanto il capitalismo neoliberale quanto l’islam politico, configurandosi come un piccolo ma persistente laboratorio di resistenza culturale.
Cristiani, Indù e la Difficile Libertà Religiosa
Più visibile, e spesso più drammatico, è il dissenso espresso dalle minoranze religiose, e, sebbene la Costituzione garantisca formalmente la libertà di culto, essa rimane subordinata al principio della ‘armonia’, un concetto ambiguo che viene interpretato come il divieto di mettere in discussione la supremazia dell’Islam.
Le comunità cristiane e indù hanno vissuto in prima persona le conseguenze di questa interpretazione selettiva, come dimostra la celebre controversia sull’uso della parola ‘Allah’ da parte dei cristiani di lingua malese, e di cui si è già discusso su questa rivista.

Non meno gravi sono le questioni legate ai matrimoni misti e alle conversioni,e, in effetti, nei casi in cui un coniuge si converte all’iIlam, i figli vengono automaticamente registrati come musulmani, spesso contro la volontà dell’altro genitore. Ne derivano battaglie legali lunghe e dolorose, che mettono in luce la difficoltà, per chi non è musulmano, di vedersi riconosciuti i diritti elementari; esistono poi numerosi episodi di demolizioni di templi indù op buddisti, oppure di problematiche per la la costruzione di nuove chiese, che completano il quadro di una discriminazione strutturale e sistematica.
Anche in Malesia, al pari di quanto avviene in Indonesia, la cittadinanza è legata all’appartenenza alla religione maggioritaria, ovvero l’Islam sunnita; evidentemente, le conversioni all’Islam sono incoraggiate, ed esistono anche guide pubbliche disponibili su questo argomento proposte da alcuni Stati.
Le Voci Indigene
Esiste, infine un dissenso meno noto, ma non meno importante, quello delle popolazioni indigene, i cosiddetti ‘Orang Asli’ della penisola e le comunità del Borneo (Sabah e Sarawak); si tratta di gruppi che spesso sono cristianizzati o legati a tradizioni religiose proprie, e che si trovano a vivere in una posizione marginale, privati di molte risorse e soggetti a pressioni di assimilazione culturale (e religiosa).
Il loro dissenso non è espresso nei termini dei diritti civili occidentali, ma attraverso la difesa della terra, delle foreste e delle pratiche comunitarie; essi denunciano l’espansione delle piantagioni di palma da olio, la deforestazione e i progetti infrastrutturali che minacciano il loro ambiente e il loro stile di vita. In questo senso, la loro resistenza è al tempo stesso sociale, culturale e spirituale, e rappresenta una delle forme più radicali di critica al modello di sviluppo imposto dallo Stato.

Il trattamento degli indigeni malesiani esemplifica molto bene il quadro generale del dissenso al modello imposto, ovvero la frammentazione; in effetti, non esiste un movimento unitario che raccolga musulmani liberali, socialisti, cristiani e indigeni. Invece, ciascun gruppo cerca di ottenere successi particolari, senza coordinarsi con altri movimenti marginalizzati; tuttavia, tutti condividono una critica alla fusione tra religione, etnia e potere politico che definisce la Malesia contemporanea.
Il dissenso, in questo Paese, non assume la forma della rivoluzione aperta, ma si manifesta nelle battaglie legali, nelle associazioni femministe, nei collettivi anarchici, o nei piccoli villaggi indigeni che difendono la foresta. Si tratta di un mosaico di resistenze, talvolta silenziose, ma capaci di incrinare il mito dell’armonia malese.
Conclusione
La Malesia costituisce un laboratorio di pluralismo imperfetto, dove il dissenso non scompare, ma si disperde in molteplici fronti; i musulmani liberali testimoniano che la religione può essere interpretata in maniera aperta e non conflittuale con la modernità. I socialisti ricordano che la giustizia sociale è la necessaria premessa per una reale armonia; le minoranze religiose, infine, denunciano la discriminazione quotidiana, mentre gli indigeni rivendicano la dignità di popoli che non vogliono essere assimilati.
Si tratta di voci spesso marginali e invisibili, che però risultano fondamentali per comprendere la complessità di un Paese che non è quello descritto dalla retorica ufficiale, ma che custodisce, nelle pieghe della sua società, un pluralismo vivo, seppure soffocatoe costantemente sotto attacco. Le dinamiche post-coloniali, evidentemente, sono ancora vive, e continuano a modellare la traiettoria della Malesia, che possiede risorse sociali per diventare un Paese plurale.
Letture Consigliate
- Teik, K. B. (2021). In dissent: Struggles for democracy in Malaysia since 2000. In The Volatility and Future of Democracies in Asia (pp. 75-97). Routledge.
- Sharom, A. (2018). Law and the judiciary: Divides and dissent in Malaysia. Southeast Asian Studies, 7(3), 391-413.
- Verma, V. (2002). Debating rights in Malaysia: contradictions and challenges. Journal of Contemporary Asia, 32(1), 108-130.