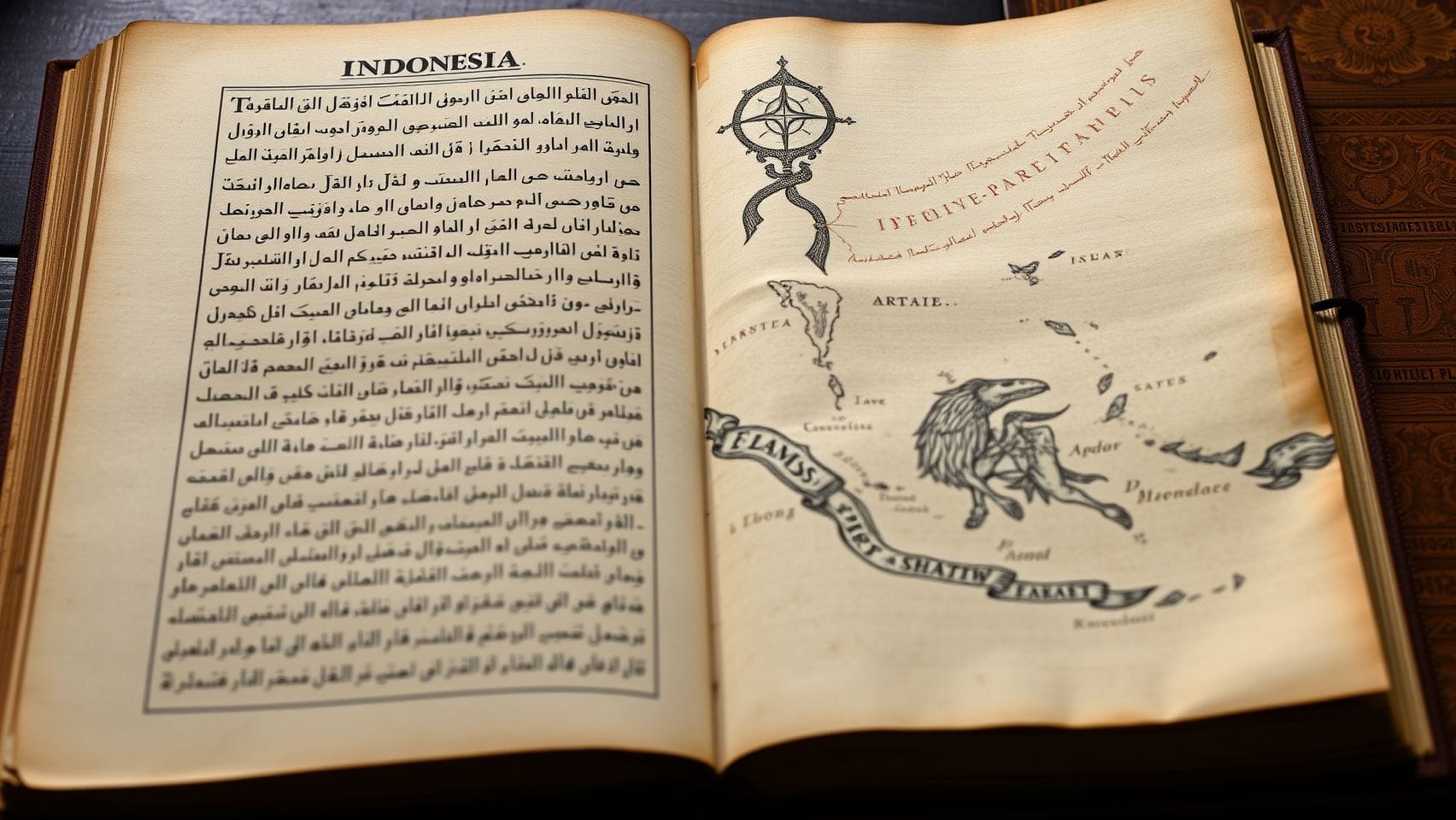- Abstract
- Introduzione – Una Laicità Sui Generis
- Religione e Potere – il Ministero degli Affari Religiosi
- La Shariah Diffusa – Un Mosaico Invisibile
- Suharto e l’Islamizzazione dall’Alto
- Università Islamiche – Laboratori di Modernità
- Diplomazia Religiosa e Soft Power
- Pluralismo Intra-Islamico e Contraddizioni
- Conclusioni – Un Equilibrio Fragile e Creativo
- Letture Consigliate
Abstract
In Indonesia, il rapporto tra Islam e Stato si presenta come una trama complessa, segnata dalla coesistenza di principi costituzionali pluralisti e da un crescente peso delle istanze religiose nella vita pubblica. Dietro l’immagine celebrata del pluralismo indonesiano, sancito dalla Pancasila e dal riconoscimento ufficiale di sei religioni, emergono tensioni meno visibili. come l’introduzione di regolamenti locali ispirati alla shariah, la discriminazione di minoranze intra-islamiche come Ahmadiyah e sciiti, e il ruolo ambivalente del Majelis Ulama Indonesia e di correnti conservatrici che hanno inciso anche sull’Islam moderato di NU e Muhammadiyah. A queste dinamiche si affiancano processi di islamizzazione dall’alto, avviati già sotto il regime di Suharto, e spinte dal basso che hanno favorito la diffusione di un Islam politico e identitario, spesso intrecciato con interessi elettorali e locali. L’Indonesia appare così come un laboratorio unico, in cui la dimensione religiosa non è riducibile a un mero fatto privato, ma agisce come forza costituente e regolativa della vita sociale e politica, rivelando le fragilità e i limiti di un pluralismo celebrato ma non sempre pienamente realizzato.
In Indonesia, the relationship between Islam and the state is a complex tapestry, marked by the coexistence of pluralistic constitutional principles and the growing influence of religious voices in public life. Behind the celebrated image of Indonesian pluralism, enshrined in the Pancasila and the official recognition of six religions, less visible tensions are emerging. such as the introduction of local regulations inspired by Sharia law, discrimination against intra-Islamic minorities like the Ahmadiyya and Shia, and the ambivalent role of the Indonesian Ulema Council and conservative currents that have also influenced the moderate Islam of NU and Muhammadiyah. Alongside these dynamics are processes of top-down Islamization, initiated under the Suharto regime, and bottom-up pressures that have favoured the spread of a political and identity-based Islam, often intertwined with electoral and local interests. Indonesia thus appears as a unique laboratory, where the religious dimension is not reducible to a mere private matter, but acts as a constituent and regulatory force in social and political life, revealing the fragilities and limitations of a celebrated but not always fully realised pluralism.
Introduzione – Una Laicità Sui Generis
L’Indonesia, un arcipelago che si estende tra l’Oceano Indiano e quello Pacifico, costituisce un crocevia di civiltà, religioni e identità che da secoli si intrecciano producendo forme politiche e culturali peculiari; con quasi 250 milioni di fedeli, pari a circa l’87% della popolazione, il Paese asiatico ospita la più grande comunità musulmana del mondo all’interno di un unico Stato. Questa cifra impressionante, tuttavia, non si traduce in un ordinamento confessionale, poiché sin dalla proclamazione dell’indipendenza, nel 1945, i padri fondatori scelsero di adottare la Pancasila come ideologia nazionale. I cinque principi che la compongono, fede in un Dio unico, umanità giusta e civile, unità nazionale, democrazia consultiva e giustizia sociale, furono pensati come collante di un mosaico etnico e religioso senza eguali, capace di assicurare la convivenza tra musulmani, cristiani, hindu, buddhisti e seguaci di tradizioni locali.
Questa decisione, apparentemente chiara e di ispirazione secolare, ha dato vita a un rapporto complesso e mai pacificato tra Islam e Stato, segnato da compromessi politici, continue negoziazioni e spazi ambigui in cui la religione si è trasformata in strumento di legittimazione, disciplina sociale e identità collettiva. Sebbene la retorica ufficiale insista sul pluralismo e sull’armonia interreligiosa, un’attenta analisi rivela un intreccio molto più denso, in cui l’Islam non è soltanto religione maggioritaria, ma dispositivo giuridico, leva diplomatica e campo di battaglia simbolico.
La stessa idea di ‘armonia’, sia religiosa che sociale, si basa sulla nozione di una società in cui i rapporti non devono (fondamentalmente) mutare nel corso del tempo, ma devono rimanere stabili; per questa ragione, le conversioni dall’Islam, anche se legalmente possibili, sono decisamente sconsigliate. A frenare una conversione, in effetti, non è solamente la pressione sociale, ma sono anche e soprattutto gli effetti legali secondari che questa decisione comporta. Si pensi, in questo senso, alle possibili ripercussioni sul matrimonio, sull’eredità e sul patrimonio che possono derivare dalla scelta di convertirsi ad un’altra religione.
Per queste ragioni, si può affermare che, seppure in presenza di una formale libertà religiosa, sancita dalla Costituzione laica del 1945, il sistema, sia legale che sociale è stato pensato per impedire la crescita delle altre religioni, almeno ufficialmente. Pertanto, si inizia ad intravvedere che la relazione tra la religione maggioritaria e le altre confessioni religiose (anche limitandosi a quelle ufficialmente riconosciute) ha una natura complessa. Quest’ultima deriva dalla storia del Paese asiatico, che ha determinato un ruolo primario dell’Islam quale fattore di identificazione sociale prima ancora che religioso, e che si traduce in un apparente paradosso.
Religione e Potere – il Ministero degli Affari Religiosi
Un elemento fondamentale per comprendere la specificità indonesiana è l’istituzione, già nel 1946, del Ministero degli Affari Religiosi (Kementerian Agama); si trattava di un unicum nel panorama internazionale. In teoria, esso è stato creato per garantire la gestione armoniosa della pluralità religiosa, ma è stato sin dall’inizio dominato da funzionari musulmani e ha operato prevalentemente come garante dell’Islam ‘ortodosso’.
Questo ministero, in effetti, non si è limitato a gestire i rapporti tra le fedi ufficialmente riconosciute (Islam sunnita, cristianesimo protestante, cristianesimo cattolico, induismo, buddhismo, confucianesimo), ma ha svolto un ruolo di arbitro all’interno dello stesso Islam, legittimando alcune correnti e marginalizzandone altre. Gruppi mistici, confraternite sufi o movimenti percepiti come eretici sono stati spesso posti ai margini, mentre venivano promosse organizzazioni come la Nahdlatul Ulama e Muhammadiyah, considerate rappresentative dell’ortodossia sunnita e del cosiddetto ‘Islam moderato’ indonesiano.
Un recente intervento sul sito del Menteri Agama (Ministero per gli Affari Religiosi) illustra perfettamente la concezione e il ruolo dell’Islam in Indonesia;
Il Direttore dell’Informazione Religiosa Islamica, Ahmad Zayadi, ha spiegato che il programma di orientamento tecnico fa parte della strategia del Ministero degli Affari Religiosi per migliorare le capacità dei predicatori. Ritiene che i predicatori svolgano un ruolo cruciale nel mantenere l’armonia sociale e nel trasmettere un messaggio islamico rasserenante.
“I predicatori sono in prima linea nella predicazione islamica all’interno della società. Pertanto, devono essere dotati di solide competenze per trasmettere efficacemente il messaggio e rafforzare i valori della moderazione religiosa”, ha affermato Zayadi a Giacarta giovedì (28 agosto 2025).
Kementerian Agama Republik Indonesia, Ada Kesempatan Bimtek Penceramah Agama Islam, Pendaftaran Dibuka hingga 4 September dan Gratis!, (C’è l’opportunità di formarsi come predicatori islamici. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 settembre e sono gratuite!), 28 Agosto 2025.
Lo Stato indonesiano, dunque, pur non proclamandosi islamico tout court, o non prevedendo un doppio binario legale, come in Malesia, ha costruito un rapporto di simbiosi con l’Islam maggioritario, piegandolo a esigenze di ordine e stabilità. Si tratta di una relazione che rivela una verità più profonda, in quanto in Indonesia, l’Islam non è mai stato solamente religione, ma anche una categoria politica e giuridica, uno strumento attraverso cui lo Stato disciplina i comportamenti e consolida il proprio potere.
Il Ministero per gli Affari Religiosi, del resto, ha sempre adottato una linea moderata, e ha cercato di bilanciare le esigenze di laicità e libertà religiosa con le ‘aspirazioni’ (i desiderata) della comunità islamica e dei suoi leaders.
La Shariah Diffusa – Un Mosaico Invisibile
La percezione diffusa secondo cui la sharia avrebbe cittadinanza soltanto ad Aceh è, a ben vedere, fuorviante; è vero che quella provincia, segnata da un lungo conflitto separatista e da una particolare storia di islamizzazione, è l’unica cui la Costituzione abbia riconosciuto il diritto di applicare formalmente la legge islamica. Tuttavia, a partire dagli anni 2000, numerose amministrazioni locali hanno introdotto ordinanze di ispirazione islamica (Perda Shariah) in diversi contesti dell’arcipelago, ma che sono tipicamente meno invasive e ‘evidenti’ rispetto a quanto avviene ad Aceh.
Questi regolamenti, pur non possedendo la forza delle leggi nazionali, plasmano la vita quotidiana dei cittadini, e, in quanto ordinanze locali, possono essere revocate e reintrodotte, ampliate o ridotte dalle amministrazioni provinciali o comunali. In molte città sono stati imposti obblighi di indossare l’hijab per studentesse e dipendenti pubbliche, sono state vietate la vendita e il consumo di alcolici, si sono introdotte restrizioni per le attività notturne e si è intervenuti persino sull’abbigliamento o sui rapporti tra uomini e donne. Si tratta, dunque, di una shariah ‘parziale’, frammentata, e praticamente invisibile agli osservatori esterni ma capace di incidere profondamente sul tessuto sociale.
Un esempio, in questo senso, è il Perda Kota Padang n. 11/2005, emanato dal governo municipale di Padang (Sumatra Occidentale); in questo caso, l’amministrazione locale imponeva il velo islamico alle studentesse musulmane. Di fatto, le scuole interpretarono questa norma e estesero l’obbligo anche a soggetti cristiani e buddisti; tale obbligo fu poi annullato dal Ministero per gli Affari Religiosi, ma una sentenza successiva della Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’intervento del ministero.
Ne emerge un pluralismo giuridico de facto che non può essere classificato secondo le categorie classiche del diritto; l’Indonesia non è uno Stato islamico, ma nemmeno uno Stato laico in senso occidentale. Si tratta, piuttosto, un arcipelago normativo, in cui il diritto nazionale convive con norme locali di matrice religiosa, generando un processo di islamizzazione strisciante, lenta ma costante, che le istituzioni promuovono attivamente, spesso a discapito delle minoranze.
Suharto e l’Islamizzazione dall’Alto
Soekarno, il primo presidente dell’Indonesia indipendente, aveva difeso con fermezza la laicità implicita della Pancasila, mentre il suo successore Soeharto incarnò una traiettoria decisamente più ambivalente; egli fu, come noto, il leader indiscusso di oltre tre decenni noti come ‘Orde Baru’, ‘Nuovo Ordine’ (1966/7-1998). Il suo regime autoritario, che si basava sul sostegno e la presenza pervasiva dell’esercito, represse duramente qualunque forma di opposizione politica e di critica sociale. Per lungo tempo, egli guardò con diffidenza i movimenti islamici, temendo che essi potessero alimentare dissenso o rivendicazioni settarie.

Eppure, a partire dagli anni Novanta, di fronte all’erosione della sua legittimità e alla crescente pressione internazionale, Soeharto intraprese una sorprendente politica di islamizzazione dall’alto, con evidenti obiettivi politici. Egli, in effetti, favorì la nascita di banche islamiche, incoraggiò l’uso dell’hijab, sostenne associazioni religiose filo-governative e cooptò leader musulmani nell’apparato politico del regime. Il dittatore militare, che per decenni aveva represso le aspirazioni islamiche, si presentava come protettore (sui generis) della fede.
Questo paradosso segnò una svolta decisiva, e la religione divenne risorsa politica, uno strumento di consenso e collante sociale; si trattò, dunque, di un esempio di ingegneria sociale, basato sull’identità islamica dell’Indonesia. Soeharto, evidentemente, non si presentò come ‘musulmano pio’, ma come il garante dell’identità nazionale, il retaggio di quella fase continua a incidere anche sull’Indonesia contemporanea, in cui la centralità dell’Islam nella vita pubblica è spesso il frutto di strategie statali più che di spontanee dinamiche popolari.
Università Islamiche – Laboratori di Modernità
La complessità del rapporto tra Islam e Stato in Indonesia emerge anche in ambito educativo, come dimostrano i pesantren, le scuole coraniche tradizionali, che hanno effettivamente mantenuto un orientamento conservatore, alimentando identità religiose radicate nelle comunità locali. Tuttavia, le università islamiche statali, le Universitas Islam Negeri (UIN), hanno spesso rappresentato spazi di elaborazione teologica e intellettuale non marginali.
In questi atenei si sono sviluppati studi comparati sulle religioni, ricerche sul rapporto tra Islam e democrazia, e dibattiti sulla compatibilità tra fede e modernità; intellettuali come Nurcholish Madjid hanno sostenuto l’idea di un Islam democratico e pluralista. Abdurrahman Wahid, invece, esponente di spicco di Nahdlatul Ulama e presidente della Repubblica dal 1999 al 2001, ha incarnato e sostenuto attivamente la possibilità di coniugare fede islamica e valori democratici.
Queste università hanno quindi contribuito a forgiare una nuova élite intellettuale musulmana, capace di reinterpretare l’Islam in chiave indonesiana, aperta e compatibile con il pluralismo; si tratta di un aspetto poco noto ma fondamentale. Mentre molte società musulmane si confrontano con tensioni tra religione e modernità, l’Indonesia ha prodotto dall’interno dell’Islam stesso risorse culturali per sostenere un progetto democratico.
Ciò nonostante, spesso si registrano tensioni con le altre fedi, come quella cristiana, che però vengono affrontate in maniera tempestiva; di fronte ad incidenti come quelli avvenuti a Sukabumi e Padang l’atteggiamento delle autorità nazionali (e spesso anche provinciali) è teso alla conciliazione e alla riparazione del trauma, non solamente economico, ma soprattutto psicologico e sociale. Le problematiche più profonde rimangono spesso a livello locale, ovvero dei singoli distretti o villaggi, mentre ai livelli superiori di governo l’approccio è differente.
Diplomazia Religiosa e Soft Power
L’Islam indonesiano non è solo una questione interna, ma, al contrario, esso è stato trasformato anche in uno strumento di politica estera e proiettato sulla scena internazionale come modello alternativo a quello mediorientale. Attraverso Nahdlatul Ulama e Muhammadiyah, due delle più grandi organizzazioni islamiche al mondo, lo Stato ha promosso un Islam relativamente moderato, tollerante e compatibile con i valori democratici.
Si tratta dell’unione tra ‘trono e altare’ in chiave indonesiana e islamica, e di un modello decisamente diverso rispetto a quello osservato ad altre latitudini, come in Medio Oriente e Africa; una sorta di ‘Islam civile’, che viene presentato come una risorsa diplomatica, volto a rafforzare l’immagine dell’Indonesia come potenza regionale e leader del mondo musulmano. In un contesto globale segnato dall’ascesa del jihadismo e dal sospetto verso l’Islam politico, Jakarta ha potuto proporsi come esempio virtuoso, rafforzando la propria influenza attraverso un soft power religioso che nessun altro Paese musulmano ha saputo esercitare con altrettanta coerenza.
Tale modello, tuttavia, presenta anche delle contraddizioni evidenti, esemplificate dalle violenze episodiche e dal concetto relativo di libertà religiosa che vige nell’Arcipelago; nonostante le contraddizioni, le differenze rispetto ad altri modelli islamici risulta evidente.
Pluralismo Intra-Islamico e Contraddizioni
Dietro l’immagine celebrata del pluralismo indonesiano si cela tuttavia una realtà più complessa e contraddittoria; in effetti, gruppi come Ahmadiyah o le comunità sciite sono stati oggetto di discriminazioni sistematiche, attacchi violenti e restrizioni legali.
L’atteggiamento dello Stato ha oscillato tra la condanna delle violenze settarie e la legittimazione delle pressioni esercitate dalle correnti sunnite maggioritarie, che si traducono nella condanne del Majelis Ulama Indonesia. In questo modo, è rimasta irrisolta una contraddizione di fondo, in quanto la tolleranza invocata nella retorica ufficiale si applica soprattutto alla coesistenza tra religioni diverse, mentre la diversità interna all’Islam viene trattata con minore generosità.
Per questa ragione, non sorprende l’ondata conservatrice che ha interessato l’Indonesia negli ultimi anni, e che non si traduce solamente in un maggior spazio riservato a predicatori ‘salafiti’, sia indonesiani che stranieri, ma anche ad una sorta di irrigidimento dell’Islam ‘moderato’ indonesiano. In effetti, la gestione delle minoranze intra-islamiche rivela un volto meno noto ma centrale della politica indonesiana; non è soltanto nella relazione con i cristiani, gli hindu o i buddhisti che si misura la capacità di un paese di garantire pluralismo, ma anche, e forse soprattutto, nel modo in cui affronta la complessità interna alla religione maggioritaria.
Tale complessità, affrontata spesso con coraggio in ambito accademico, viene spesso esemplificata a livello politico; l’uso dell’Islam politico rimane una costante del cosiddetto ‘Islam Nusantara’, ma viene usato per rafforzare l’identità islamica dell’Indonesia, piuttosto che per discriminare direttamente le minoranze ed escluderle dalla vita politica e sociale.
Conclusioni – Un Equilibrio Fragile e Creativo
Dalle osservazioni precedenti, dovrebbe essere evidente che in Indonesia il rapporto tra Islam e Stato sfugge a qualsiasi semplificazione; non si tratta, in effetti, di laicità in senso pieno (separazione tra sfera religiosa e civile), ma nemmeno una teocrazia (come in Iran o in Afghanistan) bensì una negoziazione costante, un compromesso in movimento che si reinventa di fronte a nuove sfide storiche e sociali
Tale ambiguità ha garantito una sorprendente resilienza, e ha permesso alla (fragile) democrazia indonesiana di sopravvivere a crisi economiche, attentati terroristici e conflitti interreligiosi, senza collassare o cedere alle pressioni islamiste. La Pancasila, in effetti, è uno strumento decisamente flessibile, e, in assenza di una sua interpretazione ‘autentica’ o ufficiale’, essa ha consentito alla democrazia di rinascere e di non scomparire del tutto.
La peculiarità indonesiana, del resto, consiste proprio nell’ambivalenza del suo modello di base, in cui lo Stato proclama la neutralità religiosa, ma, allo stesso tempo, considera l’Islam come parte integrante del proprio funzionamento. E’ proprio in questa tensione che risiede la chiave per comprendere non solamente la traiettoria del più grande paese islamico del mondo, ma anche le sfide più ampie del rapporto tra Islam, democrazia e modernità nel XXI secolo.
Letture Consigliate
- Lindsey, T., & Pausacker, H. (Eds.). (2016). Religion, law, and intolerance in Indonesia. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Fenton, A. (2016). Faith, intolerance, violence and bigotry: Legal and constitutional issues of freedom of religion in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 10(2), 181-212.
- Farid, M. (2018, September). Religious Intolerance and the Problematic of Religious Radicalism in Indonesia. In 3rd International Seminar on Islamic Thought (pp. 45-52).