- Introduzione
- Radici Storiche e Identità
- Quadro Legale e Istituzionale
- Discriminazioni Sociali e Culturali
- Violenza Settaria e Insicurezza
- Relazioni con lo Stato e Identità
- Conclusione
- Letture Consigliate
In Egitto, i cristiani copti rappresentano una delle comunità più antiche e longeve del Paese, che però affrontano discriminazioni e abusi sistematici da parte della maggioranza sunnita; le recenti riforme hanno cercato di modificare questa situazione, ma una piena integrazione e riconoscimento dei copti nella vita nazionale rimane ancora un obiettivo difficile da raggiungere.
In Egypt, Coptic Christians represent one of the oldest and longest-standing communities of the country, yet they face systematic discrimination and abuse from the Sunni majority. Recent reforms have attempted to change this situation, but full integration and recognition of Copts in national life remains a difficult goal to achieve.
Introduzione
La comunità copta in Egitto rappresenta una delle più antiche comuità cristiane del mondo, radicata in una storia che risale ai primi secoli dopo Cristo e intimamente intrecciata con l’evoluzione del Paese stesso. Attualmente, i Copti costituiscono circa il 10–15% della popolazione egiziana e sono, a tutti gli effetti, la più numerosa minoranza religiosa del mondo arabo; tuttavia, la loro presenza non si riduce a un semplice dato statistico, ma testimonia una continuità storica, culturale e spirituale che ha resistito a secoli di trasformazioni e pressioni politiche, religiose e sociali. Vivere come minoranza in un contesto a prevalenza musulmana ha significato, e significa tuttora, confrontarsi con una dialettica complessa, costituita da momenti di pacifica convivenza e di condivisione quotidiana, ma anche di discriminazioni strutturali, episodi di violenza e marginalizzazione. L’analisi della condizione copta in Egitto, pertanto, non può limitarsi alla descrizione delle difficoltà, ma deve anche cogliere le dinamiche di resilienza e le risorse che questa comunità ha saputo elaborare per preservare la propria identità e per continuare a svolgere un ruolo vitale nel tessuto della società egiziana.
Si ricorda, a questo proposito, il duro colpo subito per mano di ISIS, che proprio in Egitto mise in atto uno dei suoi attacchi più sanguinari; tra il 2016 e il 2017 lo Stato Islamico compì numerosi attacchi contro le chiese copte in Egitto, anche durante le celebrazioni religiose, mietendo morti, feriti e procovando terrore tra i cristiani egiziani.
Radici Storiche e Identità
Per comprendere la condizione dei Copti, è necessario partire dalla loro storia, e, da questo punto di vista, si osserva che l’Egitto cristiano (pre-islamico) fu una delle culle del monachesimo, esperienza che avrebbe segnato in profondità la spiritualità cristiana in tutto il mondo. Le figure leggendarie di Antonio il Grande e Pacomio, considerati padri del monachesimo, incarnano la vitalità religiosa di un Egitto che, nei secoli, avrebbe influenzato la cristianità ben oltre i suoi confini. Con la conquista araba del VII secolo, i Copti divennero gradualmente una minoranza in un Paese sempre più islamizzato, ma conservarono una forte identità ecclesiale, linguistica e culturale. La lingua copta, ultima erede dell’egiziano antico, divenne il simbolo di un patrimonio religioso e culturale che resisteva all’assimilazione. Questa duplice appartenenza, come parte integrante della società egiziana, ma anche come custodi di una tradizione distinta, ha caratterizzato i Copti per secoli, rendendoli una componente insostituibile ma allo stesso tempo vulnerabile del mosaico nazionale.

L’identità copta è talmente radicata in Egitto da resistere al processo di islamizzazione, accelerato a partire dagli anni Ottanta, e recentemente mediante l’azione dei fratelli musulmani e dei predicatori salafiti. Spesso i predicatori presentano i copti come una categoria di persone subordinata alla maggioranza sunnita, secondo la retorica dei dhimmi; altre volte, invece, i copti sono presentati come cospiratori, traditori e alleati dell’Occidente. Ancora, questa comunità cristiana viene rappresentata come responsabile della ‘corruzione morale’ dell’Egitto (secolarizzazione, consumo di alcol, ecc.); in definitiva, i copti diventano spesso i capri esapiatori dei problemi del Paese in cui hanno una responsabilità e una visibilità politica decisamente limitata.
Quadro Legale e Istituzionale
Il rapporto dei Copti con lo Stato egiziano è segnato da una costante tensione tra riconoscimento e marginalizzazione; la Costituzione garantisce una formale libertà religiosa, ma nello stesso tempo sancisce l’islam come religione di Stato e la sharia come fonte principale della legislazione. Questa ambivalenza produce conseguenze concrete e spesso penalizzanti per la comunità copta.
Un esempio, in questo senso, è costituito dalla costruzione e dal restauro delle chiese, che rimane un terreno di forte discriminazione; sebbene la legge del 2016 abbia tentato di semplificare le procedure, in molte aree rurali i permessi rimagono difficili da ottenere e le autorità locali ostacolano attivamente i lavori. La rappresentanza politica dei Copti, poi, è decisamente inadeguata rispetto alle proporzioni demografche di questa comunità; essi risultano sottorappresentati nei parlamenti, nelle forze armate e negli apparati di sicurezza, ambiti nei quali permangono barriere invisibili che ostacolano una piena integrazione.
A queste discriminazioni si aggiungono le difficoltà legate allo status personale, in cui questioni di matrimonio, divorzio e custodia dei figli sono regolate prevalentemente dalla sharia, con esiti spesso problematici per le famiglie copte, soprattutto nei casi di conversione da o verso l’Islam. Le conversioni religiose, inoltre, sono uno dei nodi più sensibili; in effetti, il passaggio dal cristianesimo all’Islam è riconosciuto dallo Stato, mentre il percorso inverso risulta praticamente impossibile a ragione delle gravissime conseguenze legali e sociali che ne derivano.
Discriminazioni Sociali e Culturali
Oltre agli ostacoli istituzionali, i Copti subiscono discriminazioni diffuse nella vita quotidiana, come nella scuola, ambito in cui studenti e insegnanti copti possono incontrare episodi di marginalizzazione, alimentati da un curricolo che presenta l’islam come unica matrice identitaria della nazione. L’identificazione della nazione con l’Islam e con l’obbedienza al leader (sempre islamico) configurano uno Stato in cui le libertà sono subordinate alle esigenze della nazione e della religione maggioritaria, che sarebbe garante della moralità pubblica.
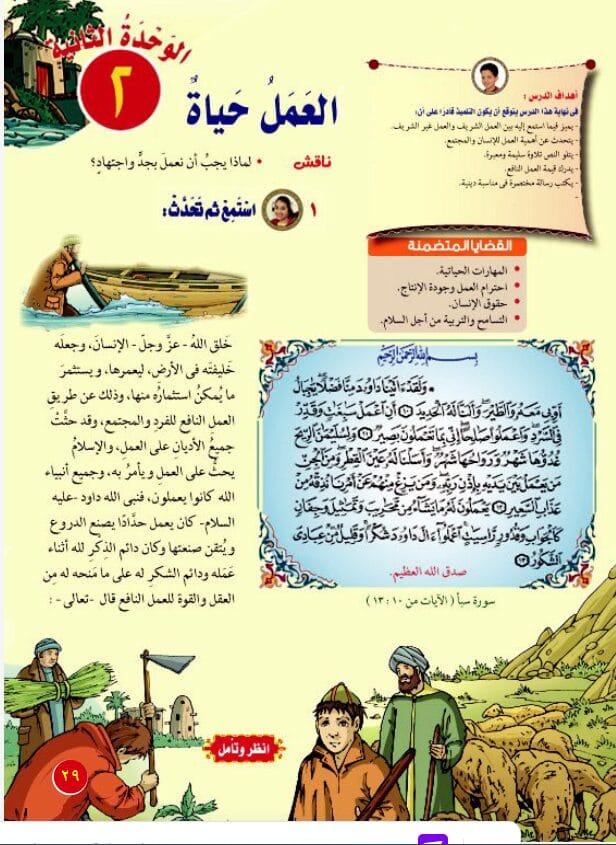
I manuali scolastici, in particolare, insistono sul legame tra valori civici e l’Islam, proposto come unica religione (di fatto), o comunque superiore rispetto alle altre; la pagina sopra riportata esorta al lavoro manuale, indicandolo come un dovere e un atto di culto islamico. Un bambino copto, evidentemente, si sentirà escluso da questa nozione, oppure non completamente incluso in questa narrativa, che tende ad escludere la diversità religiosa.
Nel mondo del lavoro, le barriere sono più sottili ma altrettanto incisive, e derivano dall’educazione esclusivista impartita negli anni della formazione scolastica; negazione di promozioni, esclusione dai settori strategici dello Stato, preferenza sistematica per candidati musulmani. Nelle zone rurali dell’Alto Egitto, più tradizionaliste e segnate da dinamiche tribali, i Copti diventano spesso bersaglio di pressioni sociali, attacchi violenti o esclusioni da reti economiche vitali per la sopravvivenza delle famiglie.
Violenza Settaria e Insicurezza
La violenza settaria contro i Copti è uno dei capitoli più drammatici della loro storia recente, testimoniato dagli attentati contro chiese, quartieri cristiani o pellegrini, che hanno lasciato cicatrici profonde nella società egiziana. Si ricordano, in questo senso, gli attacchi durante le festività di Pasqua e Natale, così come il massacro di Minya del 2017, in cui un autobus di pellegrini fu assalito da miliziani; in molti casi, la risposta statale è apparsa lenta, insufficiente o poco determinata nel perseguire i responsabili. L’adozione di pratiche di ‘riconciliazione’ extragiudiziarie, in cui le autorità locali preferiscono mediare tra comunità musulmane e cristiane piuttosto che punire i colpevoli, come avviene anche in altri Paesi islamici o a maggioranza islamica (e.g. Indonesia) ha ulteriormente minato la fiducia dei Copti nello Stato di diritto, rafforzando un clima di impunità per l’intolleranza religiosa.
Secondo i media, il Presidente ha inaugurato una nuova fase di convivenza, ma tali dichiarazioni sembrano vuote di significato nella misura in cui l’istruzione continuerà ad essere basata su un nazionalismo islamico. Particolarmente delicata, poi, è la condizione delle donne copte, come testimoniato da rapporti in cui si documentano casi di rapimenti, matrimoni forzati e conversioni imposte, fenomeno che colpisce soprattutto le aree rurali, dove le reti sociali sono più rigide e il controllo delle famiglie più difficile da esercitare. Anche in contesti urbani, le donne copte affrontano molestie legate alla loro identità religiosa. A questo quadro, poi, si aggiunge l’uso strumentale delle leggi sulla blasfemia, che espone i cristiani al rischio di accuse arbitrarie, spesso motivate da rivalità personali o dispute locali, ma capaci di distruggere vite e comunità.
Di fronte a queste difficoltà, la comunità copta ha sviluppato forme straordinarie di resilienza, mediante chiese e monasteri, che non sono solamente dei luoghi di preghiera, ma autentici centri di socialità, educazione e solidarietà. La Chiesa ortodossa copta, sotto la guida di figure carismatiche come Papa Shenouda III e l’attuale Papa Tawadros II, ha rafforzato il ruolo aggregativo della comunità, creando una fitta rete di scuole, ospedali e servizi sociali che suppliscono alle carenze statali. Anche i media copti, come il settimanale Watani o la rivista ecclesiastica Kiraza, contribuiscono a consolidare l’identità collettiva e a trasmettere la memoria storica. Parallelamente, la diaspora copta in Europa e Nord America ha assunto un ruolo cruciale; attraverso associazioni e campagne di sensibilizzazione, ha reso visibile la condizione dei Copti sulla scena internazionale, esercitando pressioni diplomatiche sul governo egiziano.
Relazioni con lo Stato e Identità
Negli ultimi anni, il regime egiziano ha cercato di migliorare la propria immagine in materia di diritti delle minoranze; si inseriscono in questo quadro gesti simbolici come la partecipazione del presidente Abdel Fattah al-Sisi alle celebrazioni del Natale copto o l’inaugurazione della cattedrale della Natività nella nuova capitale amministrativa. Si tratta di eventi che hanno avuto un forte impatto mediatico, mostrando una volontà, almeno formale, di inclusione. Tuttavia, la distanza tra simboli e realtà rimane ampia, in quanto le riforme legali introdotte, come la regolamentazione delle chiese o le proposte di legge sullo status personale dei cristiani, si scontrano ancora con resistenze burocratiche e culturali che ne limitano l’efficacia concreta.

La questione copta è anche, e soprattutto, una questione di identità nazionale, e da un lato, i Copti rivendicano il loro ruolo di eredi autentici della civiltà faraonica e di componente storica e insostituibile della nazione egiziana. Dall’altro, la costruzione del nazionalismo moderno, soprattutto a partire dal XX secolo, è stata spesso declinata in termini islamici, relegando i Copti ad una posizione marginale nel discorso identitario ufficiale. Questo dualismo alimenta tensioni e sospetti, rendendo difficile una piena integrazione, che probabilmente non è un obiettivo percorribile nel breve termine, senza riforme strutturali e una rigenerazione della classe dirigente egiziana, ripiegata su posizioni conservatrici.
Conclusione
La condizione dei Copti in Egitto rappresenta un prisma attraverso cui leggere le contraddizioni del Paese, che presenta una comunità radicata e vitale, capace di una straordinaria resilienza; allo stesso tempo, tuttavia, i copti rimangono una minoranza oggetto di discriminazioni quotidiane, violenze periodiche e un riconoscimento istituzionale ancora incompleto. Le difficoltà affrontate dai Copti mostrano quanto sia fragile la condizione delle minoranze religiose in contesti segnati da una maggioranza islamica, al pari di quanto si osserva in altri contesti. Tuttavia, la loro storia non è soltanto una cronaca di oppressioni,ma testimonia anche la capacità di resistere, di reinventarsi e di partecipare attivamente alla vita nazionale.
La sfida per l’Egitto contemporaneo consiste nel trasformare i gesti simbolici in riforme sostanziali, garantendo ai Copti non solamente visibilità, ma pieni diritti di cittadinanza; in questa prospettiva, la questione copta diventa più di un problema minoritario, e si configura, piuttosto, come un banco di prova per la maturità democratica e pluralista del Paese. Se l’Egitto saprà riconciliare la sua eredità faraonica, cristiana e islamica in una sintesi inclusiva, i Copti non saranno più considerati come una minoranza sopravvissuta, ma come parte essenziale e paritaria della nazione.
Letture Consigliate
- Aalouane, F., & Rebbouj, A. (2022). The rights of religious minorities in Muslim-majority states: A comparative study of Egyptian Copts and Iraqi Christians. Rowaq Arabi.
- Samir, M. (2022). Intertwined hierarchies: The intersection of religion and gender in the personal status laws of Orthodox Copts in Egypt. Rowaq Arabi.
- Egyptian Commission for Rights and Freedoms. (2025, July). Freedom of Belief and Citizenship Bulletin: July 2025 highlights.

