Abstract
I Gesuiti sono stati inviati in diverse terre che erano parti degli imperi europei, come l’Algeria Francese, e, in tale ambito, essi hanno esercitato con efficacia i loro sforzi missionari, basati su un atteggiamento accomodante rispetto alla cultura locale, ma anche alla religione islamica. Quest’ultima non era considerata come un oggetto da denigrare, ma da comprendere, per usare gli elementi positivi in essa presenti e incoraggiare la conversione al cattolicesimo.
The Jesuits were sent to various lands that were parts of European empires, such as French Algeria, and in this context, they effectively carried out their missionary efforts, based on an accommodating attitude towards the local culture, but also towards the Islamic religion.The latter was not considered an object to be denigrated, but to be understood, in order to use the positive elements present in it and encourage conversion to Catholicism.
Gesuiti – Una Presenza Globale
L’ordine religioso dei gesuiti, fondato da Ignazio di Loyola nel XVI secolo, è presto diventato un ordine presente nel mondo intero, dalle Indie all’America del Sud all’Africa; si tratta di una sorta di una vera e propria rete che ancora oggi è capace di esercitare una certa influenza anche in terre che sono storicamente, e attualmente, a maggioranza islamica, come l’Indonesia. L’elezione di Papa Francesco, nel 2013, ha dato ulteriore impulso a un ordine religioso che, sebbene osteggiato nel corso dei secoli, è riuscito a sopravvivere e svilupparsi, diventando una delle realtà più rilevanti della chiesa cattolica e della società.
Secondo l’autorevole sito ‘Jesuits Global’,
As of 1 January, 2022, there were 14,439 Jesuits in the world. They were broken down as follows: 583 novices, 2,587 scholastics, 837 brothers and 10,432 priests.
The geographical distribution can be summarised as follows: South Asia (India and surrounding countries): 3,955; Asia-Pacific: 1,481; Africa: 1,712; Europe (including Central and Eastern Europe, Western Europe and Southern Europe): 3,386; North America (specifically Canada and the United States): 2,046; Latin America (including Mexico and the Caribbean): 1,859.
Al 1 gennaio 2022, c’erano 14.439 gesuiti nel mondo. Erano suddivisi come segue: 583 novizi, 2.587 scolastici, 837 fratelli e 10.432 sacerdoti.
La distribuzione geografica può essere riassunta come segue: Asia meridionale (India e paesi circostanti): 3.955; Asia-Pacifico: 1.481; Africa: 1.712; Europa (inclusa l’Europa centrale e orientale, l’Europa occidentale e l’Europa meridionale): 3.386; Nord America (specificamente Canada e Stati Uniti): 2.046; America Latina (incluso Messico e Caraibi): 1.859.
The Society of Jeusus in Numbers, 2022 Edition
Anche se il processo di secolarizzazione ha determinato una consistente diminuzione del numero di religiosi, specialmente in Europa, la presenza della Societas Jesus è consolidata ed è in espansione in Asia e Africa. Si tratta di due realtà in cui il numero di sacerdoti e di fedeli cattolici è in costante aumento, al contrario di quanto avviene in altre aree del mondo, e che sono state interessate dal fenomeno della colonizzazione.
Tale situazione dipende, essenzialmente, dalla strategia adottata, che ha tendenzialmente accordato una maggiore importanza all’influenza culturale rispetto alla semplice conversione religiosa; come è stato già discusso su queste pagine, in effetti, i gesuiti hanno cercato, talvolta in maniera controversa, di adattarsi alle usanze locali, allo scopo di proporre un messaggio che potesse essere accettato più facilmente.
La Civiltà Cattolica – Un Arsenale Culturale
Parte della strategia dei Gesuiti, come noto, è stata la promozione di una cultura cattolica, mediante la creazione di scuole e di una stampa adeguata a veicolare i valori cattolici; tra i periodici pubblicati, emerge sicuramente ‘La Civiltà Cattolica’, ‘LCT’, fondata nel 1850. Si tratta del periodico cattolico più antico ancora in circolazione e diffuso nelle librerie e biblioteche del mondo intero, la cui longevità si deve, probabilmente, all’ampiezza e profondità delle tematiche affrontate.
Nelle pagine di LCT, in effetti, si trovano non solamente le encicliche e documenti pontifici, ma anche ampie riflessioni della società e degli avvenimenti principali, nonché dei personaggi che hanno caratterizzato 175 anni di storia. La chiave di lettura, come si può facilmente immaginare, non è solamente o prettamente religiosa, ma culturale; non mancano, ovviamente, interventi dottrinali, ma questi non costituiscono la maggioranza del materiale che si può rinvenire sulla Civiltà Cattolica, specialmente dopo il Concilio Vaticano II.
La Civiltà Cattolica, in effetti, contiene alcune analisi di eventi fondamentali per la storia mondiale, e non solamente italiana, come testimonia questo passaggio, che critica aspramente il liberalismo,
Riuscite vittoriose della madre patria le colonie inglesi d’America proclamarono nel 1776 la propria indipendenza, costituendosi in Stati, retti a governo democratico ed insieme confederati per la coraune difesa. Fu questa l’origine della grande repubblica degli Stati Uniti, la quale ricevette la sua definitiva costituzione nel Congresso di Filadelfia dell’ anno 1787. In virtu di siffatta costituzione, e atteso lo spirito intraprendente e tenace nell’ ossequio alia legge, proprio della stirpe Anglo-Sassone, quei popoli salirono in breve a tanta altezza di civile coltura da riscuotere l’ammirazione del mondo intero. Ma quella costituzione è tutt’altro che un portato dei principii liberaleschi.
(La Civiltà Cattolica, Il Liberalismo, 1876, p. 278)
Secondo la visione del tempo, la prosperità degli Stati Uniti d’America si basava non sul presunto liberalismo, ma sui principi religiosi (sia cattolici che protestanti) a cui tale nazione si ispirava, che erano opposti al liberismo; si tratta di un esempio, tra i tanti, che si potrebbero trarre dalla Civiltà Cattolica, ed in particolare dai primi anni di edizione.
Non mancano, poi, critiche all’Islam e ai musulmani, chiamati ‘Maomettani’, un’accezione che non descrive tanto la fede religiosa quanto la civiltà (avversa) che essa rappresenta; per questa ragione, i toni sono particolarmente accesi, come dimostra questo passaggio sulle popolazioni balcaniche.
La popolazione indigena appartiene alia famiglia serbo-croata, e professa tre religioni differenti : la cattolica, la greca e la maomettana. Queste tre religioni formano altrettanti carapi ostili l’uno all’atro, e si detestano reciprocamente a malgrado della comune loro origine slava. I maomettani superano di gran lunga in fanatismo le altre due confessioni; sono costoro i discendenti di quei Bosniaci rinnegati che a tempo dell’invasione degli Osmanlis (i turchi, ndr) anteposero alla fede cristiana il giogo musulmano e i vantaggi civili inerenti alla loro sottomissione.
(La Civiltà Cattolica, Cose Straniere, V, 1876, p. 380)
Da questo brano risulta evidente che l’Islam viene considerato un mezzo per avere dei vantaggi, e l’allineamento con questa civiltà spiegherebbe gli eventi che sono avvenuti in questa regione del mondo; si tratta di una sorta di un’analisi geopolitica cattolica ante litteram, che appare sorprendente per la sua modernità.
Ritengo che questi due passaggi, tra i molti che si potrebbero citare, siano sufficienti per mostrare l’ampiezza della prospettiva offerta; non si tratta solamente di una critica, ma di una rilettura cattolica degli avvenimenti, una rilettura credibile e coerente con il magistero della chiesa e i valori della società occidentale. Da notare come, nonostante le polemiche ancora vive con il protestantesimo, questa religione venga indicata come un fattore di benessere e prosperità per la società statunitense.
L’Ottimismo Filo-Islamico
I missionari inviati nelle terre coloniali, che spesso erano islamiche, non hanno sempre adottato un atteggiamento ostile; al contrario, molti di essi hanno espresso una visione filo-islamica, nel senso che essi hanno apprezzato e cercato di usare alcuni elementi dell’Islam per creare futuri predicatori indigeni del Vangelo. Per questa ragione, si parla di ‘ottimismo filo-islamico’, un atteggiamento che perdura tuttora, e non solo tra gli ambienti missionari, rispetto ad alcuni elementi della religione islamica; nel corso del XIX secolo, si trattava di una strategia dei gesuiti per indurre i musulmani ad abbracciare il cattolicesimo, ed era decisamente controversa.
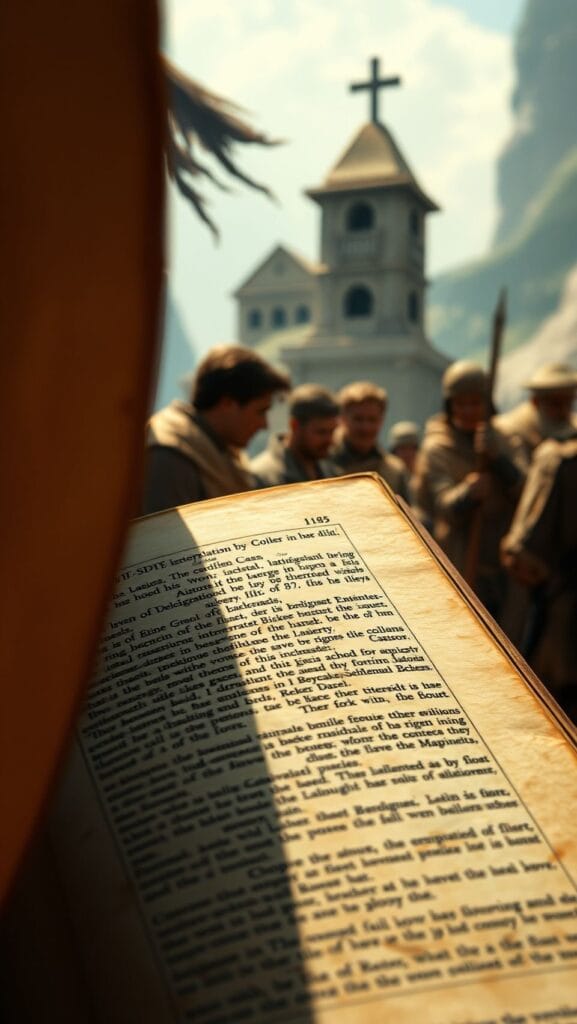
Una visione di questo genere, evidentemente, presupponeva che l’Islam contenesse elementi positivi, e si opponeva a coloro che invece vedevano solamente errori da condannare; esponenti di questa corrente di pensiero e metodologia sono sicuramente Veuillot e Ducat, due gesuiti attivi in Algeria nell’ultimo quarto del XIX secolo. In entrambi i casi, si osserva in essi la speranza che, dopo la conversione, i nuovi fedeli cattolici conservino lo spirito pietistico tipico dell’Islam, allo scopo di diventare agenti nativi del Vangelo.
L’idea alla base di questa strategia era quella di creare una comunità autoctona, con una maggiore probabilità di cristianizzare le aree sottoposte al dominio islamico; la conformazione religiosa e culturale, evidentemente, era strumentale all’idea di un impero unificato, in una sola religione e una cultura omogenea nel limite del possibile. Per questa ragione, non sorprende il tentativo della Francia di rendere le colonie uno specchio della madre-partria, non solamente dal punto di vista esteriore (edifici, ecc.) ma anche, e soprattutto culturale.
Erano diversi i gesuiti ad essere fautori di un approccio accomodante, e non apertamente opposto alla cultura locale, anche rispetto ai musulmani; alcuni missionari, poi, ritenevano necessario creare una congregazione religiosa che si specializzasse nelle missioni ai musulmani. In altre parole, si sarebbero dovute creare delle unità speciali di missionari specializzati nell’evangelizzazione di coloro che aderivano alla fede islamica.
I Gesuiti, poi, mettevano a disposizione scuole per i convertiti o per coloro che si preparavano a diventare cristiani, orfanotrofi, ospedali, e intere parrocchie popolate esclusivamente, o prevalentemente, da cristiani indigeni. Un’altra pratica raccomandata consisteva nei matrimoni tra europei e arabi cristianizzati, allo scopo di favorire l’inculturazione e la creazione di un cristianesimo arabo; ancora, si pensi alla composizione di preghiere cristiane che includevano anche pezzi di preghiere islamiche, ovviamente non in contrasto con la fede cristiana, come le formule puramente monoteistiche, che non escludessero Cristo e il suo ruolo di redentore.
La Missione Algerina
Le missioni dei gesuiti, come quella in Algeria, sono state segnate da diverse battute d’arresto e ostacoli, nonostante le abili strategie messe in atto; negli anni Cinquanta del XIX secolo, il sentimento prevalente ero lo scoraggiamento. In questo periodo, in effetti, il governo coloniale di sostenere una missione nei territori della colonia, ma anche per altri motivi, come difficoltà all’evangelizzazione di queste aree, che probabilmente sono state sottovalutate o non previste.
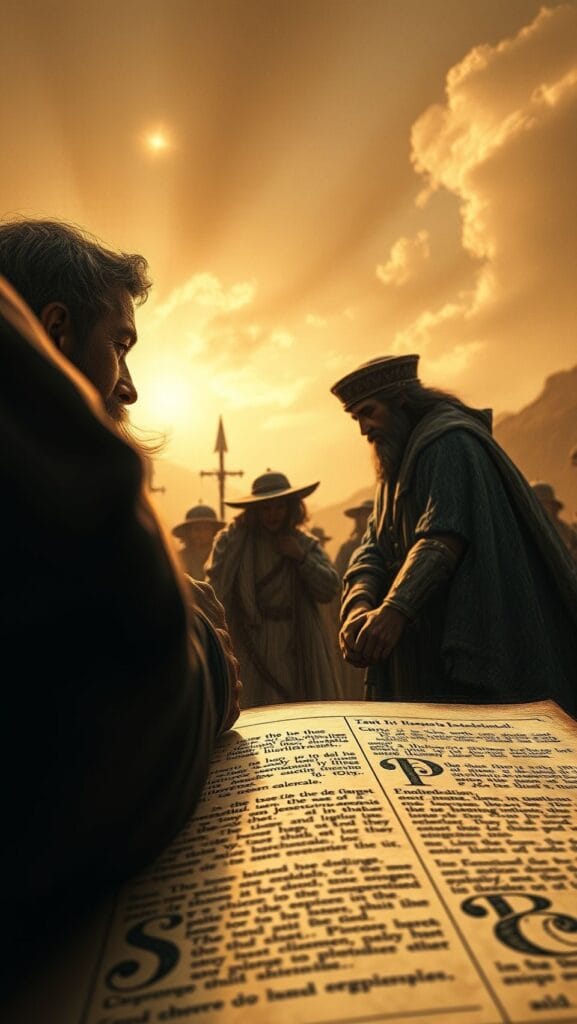
Il Superiore dei Gesuiti in Algeria, in effetti, riteneva che le risorse del fallito seminario costruito nel 1849-1850 potessero essere rilocate a Constantine; venne anche suggerito che alcuni gesuiti potessero seguire il modello inaugurato nelle Indie, vivendo seguendo i costumi della popolazione autoctona, allo scopo di guadagnarsi una buona reputazione ed avere una maggiore efficacia nella predicazione del Vangelo. Si trattava di progetti, che, tuttavia, necessitavano di fondi e di personale che mancavano; per questa ragione, gli sforzi missionari vennero limitati a progetti meno ambiziosi intorno alla città di Constantine (la diocesi verrà creata nel 1866).
Nel 1856, i gesuiti furono estromessi dal lavoro pastorale dall’Arcivescovo di Algeri, Louis Antoin Augustin Pavy, che raccolse risorse e persone per l’evangelizzazione, mentre i gesuiti erano percepiti come elementi estranei, in quanto indipendenti, rispetto alla gerarchia della diocesi. Per questa ragione, i padri della Compagnia di Gesù decisero di concentrare i loro sforzi sulla popolazione non europea della città algerina; la loro cacciata dalla diocesi li costrinse, in effetti, a prendere dimora ‘presso gli infedeli’. Una situazione del genere, evidentemente, era altamente favorevole al contatto diretto con i musulmani, evitando mediazioni che potevano rendere la loro predicazione meno efficace. La speranza era quella di concentrarsi sul profilo educativo, con particolare attenzione per i bambini, anche se ovviamente gli adulti erano oggetto dei loro sforzi.
Nel 1857, venne creata un’associazione per la conversione dei musulmani africani, allo scopo di incoraggiare il risveglio spirituale del continente africano; si trattava di un’associazione di preghiera, che però servì a creare una comunità invisibile e a sostenere gli sforzi missionari. Le tensioni con l’ordinario locale, tuttavia, non cessarono, e, sebbene il vescovo approvò la nuova associazione, egli subordinò questa concessione a diversi caveat. La nuova associazione, in effetti, avrebbe dovuto aiutare a raccogliere il denaro necessario per costruire la cattedrale di Algeri, e si doveva astenere dal pubblicizzare le sue attività fino a quando la campagna di fundraising fosse stata completata, allo scopo di non alienare i cattolici moderati a causa dell’intenzione di proselitismo.
Lo stesso nome dell’associazione, inoltre, venne mutato, e i ‘poveri musulmani’ divennero i ‘poveri infedeli’; i gesuiti si opposero a questa decisione, nel timore che il cambiamento della denominazione potesse urtare la sensibilità dei musulmani, indebolendo la loro predicazione. Del resto, il vescovo Pavy non sembrava realmente interessato alle missioni, se non per giustificare la raccolta di fondi per la sua diocesi. Ciò nonostante, i gesuiti seppero sfruttare questo attegiamento per far sopravvivere la loro associazione; Pavy apparteneva alla folta schiera di coloro che ritenevano adottare una strategia che non fosse basata sull’accomodamento, bensì sulla denigrazione dell’Islam, un atteggiamento ostile che risultava più comprensibile e giustificabile per gli europei.
L’Atteggiamento Verso i Musulmani
L’atteggiamento prevalente dei cattolici verso l’Islam, nel corso del XIX secolo, era caratterizzato da un approccio ostile, che mirava a porre in risalto la natura ‘eretica’, quando non ‘pagana’ dell’Islam; il vescovo di Constantine, da questo punto di vista, non costituiva certamente un’eccezione. Si consideri, a questo proposito, che nel corso di un’omelia tenuta per la Quaresima, egli pronunciò un sermone decisamente polemico contro il ‘Mohammedanismo’, o ‘Maomettismo’.
A questa strategia, basata sulla denuncia degli errori (dal punto di vista cattolico) dei musulmani, si opponeva quella più conciliante, e spesso controversa e mal compresa, di chi, invece, cercava di guadagnarsi la stima dei fedeli islamici, senza ovviamente rinunciare alla loro evangelizzazione. In tale, (ed altre) occasioni, egli ribadì la convinzione secondo cui non vi fosse nulla di buono o di positivo nell’Islam, che, invece, andava combattuto e non addomesticato. La stessa cattedrale per cui Pavy stava raccogliendo i fondi, sarebbe servita a ricordare la vittoria contro ‘i barbari pirati di Algeri’, ovvero i musulmani.
Nonostante le difficoltà, l’Associazione di Preghiera vide aumentare i suoi membri, che, verso la fine del 1858 erano circa 10,000; inoltre, anche gli sforzi missionari sembravano raccogliere i primi risultati positivi, dopo anni di scoraggiamento. La vittoria più tangibile, probabilmente, è stata la conversione al cattolicesimo di due fratelli, Garmi e Mouloud; tali conversioni, in effetti, furono attribuite all’associazione di preghiera.
Le prime conversioni, in aggiunta, furono seguite da altre, e si trattava di esponenti in vista di Constantine; di conseguenza, i gesuiti affermarono che il loro metodo funzionava, in quanto queste persone sembravano credere da musulmane ad alcuni dogmi cattolici, confermando che l’Islam conteneva anche elementi positivi. Del resto, i primi battesimi non avvennero mai senza l’autorizzazione delle famiglie di origine, che si impegnavano anche a rinunciare a fare pressioni affinché i convertiti tornassero alla fede islamica.
Conclusioni
I Gesuiti furono presenti in Algeria , e in particolare a Constantine, dove organizzarono una missione e un’associazione di preghiera per la conversione dei musulmani; contrariamente a coloro che adottavano un atteggiamento intransigente, i gesuiti cercarono di guadagnarsi la fiducia dei musulmani, rinunciando a denigrarli ed attacarli frontalmente. Il caso algerino, dunque, sembra confermare l’efficacia dell’accento posto sulla cultura piuttosto che sulla religione da parte dei membri della Compagnia di Gesù; nonostante le difficoltà incontrate, le loro iniziative hanno un certo successo, e la fede cattolica inizia a radicarsi in un ambiente ostile come quello in esame.
Letture Consigliate
- Peterson, J. W. (2022). Sacred rivals: Catholic missions and the making of Islam in nineteenth-century France and Algeria (p. 304). Oxford University Press.
- Greco, G. (1976). LA” CIVILTA’CATTOLICA” NEL DECENNIO 1850-1859: Appunti sulla pubblicistica reazionaria durante il Risorgimento. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, 6(3), 1051-1095.
- Vermeren, P. (2016). Chapitre X. L’Algérie terre de mission: les Pères blancs et le mythe kabyle. Collection Histoire, 149-164.

