- Censura di Stato
- La Memoria di una Libertà Imperfetta
- La Restaurazione del Silenzio
- La Rimozione delle Donne dallo Spazio Pubblico
- La Diaspora come Nuova Sfera Pubblica
- Il Giornalismo in Esilio come Resistenza Politica
- L’Informazione Clandestina e il Nuovo Spazio Digitale
- Conclusione – La Parola come Forma di Sopravvivenza
- Letture Consigliate
Dopo la presa del potere da parte dei talebani, in Aghanistan la stampa è stata ristretta, e i media ufficiali riflettono la propaganda nazional-religiosa dell’Emirato; ciò nonostante, in esilio sono stati organizzati o trasferiti media che raccontano il Paese reale, senza censure.
After the Taliban took power, the press in Afghanistan was restricted, and official media reflect the Emirate’s national-religious propaganda; Nevertheless, media that tell the story of the real country, without censorship, have been organised or transferred into exile.
Censura di Stato
Nel panorama contemporaneo della comunicazione globale, il caso afghano rappresenta una delle tragedie più emblematiche del rapporto tra potere, religione e libertà; la storia recente del Paese (dal 2021 in poi) mostra come il controllo dell’informazione non sia soltanto una questione tecnica o politica, ma un mezzo di dominio spirituale, una forma di potere. Quest’ultima risulta coerente con un’applicazione della sharia che trova pochi emuli nel mondo islamico; non sorprende, dunque, che il giornalismo, in Afghanistan, non è sia una semplice professione, ma che sia e continua a rappresentare campo di battaglia tra l’idea di libertà e la pretesa della verità assoluta di cui si fanno portavoci ed interpreti esclusivi le istituzioni statali.

La riconquista di Kabul da parte dei talebani nell’agosto del 2021, ha segnato un punto di volta negativo per la fragile infrastruttura della stampa afghana, faticosamente costruita in vent’anni di esperimenti democratici. La restaurazione dell’emirato ha comportato, per il Paese, una nuova stagione di censura, in cui l’informazione sopravvive solamente all’estero, lontana dal controllo e dalla pressione delle autorità dello Stato islamico. Attualmente, il giornalismo afghano è un corpo spezzato, formato, da un lato, dalla censura o auto-censura dei media ufficiali, dall’altro, le voci esiliate che tentano di salvare la memoria di un Paese ridotto all’oblio.
La Memoria di una Libertà Imperfetta
Per comprendere la portata del cambiamento avvenuto, è necessario ricordare la stagione, breve ma intensa, che precedette la caduta di Kabul; dopo il 2001, l’Afghanistan conobbe un sorprendente risveglio mediatico. Centinaia di testate, televisioni e radio nacquero in tutto il Paese, spesso sostenute da fondi internazionali, da ONG e da organizzazioni per i diritti umani e la democrazia; l’apertura dei media fu percepita come uno dei segni tangibili del nuovo ordine politico. Dopo molti anni, i media si occupavano di corruzione, di diritti delle donne, di economia, di politica locale; dopo decenni di guerre, la parola pubblica tornava ad avere un peso nella vita del Paese.
Quel pluralismo era tuttavia fragile, e la maggior parte dei media dipendeva da finanziamenti esterni, mentre le strutture erano precarie e il tessuto professionale dei giornalisti rimaneva esile; la libertà, più tollerata che garantita, si muoveva dentro confini ancora incerti; eppure, anche in tale contesto, si manifestava qualcosa di nuovo. Si profilava la possibilità che l’Afghanistan si raccontasse da sé, non più come oggetto di propaganda o di pietà internazionale, ma come soggetto pensante.
Quando i talebani tornarono al potere, quella fragile architettura cedette improvvisamente, implodendo sotto la scure della censura; le redazioni furono chiuse, i giornalisti minacciati, e molti di essi fuggirono in Pakistan, Iran o Turchia, mentre altri cercarono asilo in Europa o in America. In poche settimane, quello che rimaneva di due decenni di democratizzazione (seppure imperfetta) venne cancellato. Il ritorno dell’Emirato Islamico segnò dunque, la restaurazione di un regime, e soprattutto la distruzione di una voce collettiva dotata di una certa indipendenza dal governo o dall’apparato militare.
La Restaurazione del Silenzio
La nuova dirigenza talebana non ha mai nascosto la propria concezione dell’informazione, e nei loro discorsi ufficiali, i leader del movimento non hanno mai modificato la loro concezione, secondo cui la libertà di stampa è un concetto ‘occidentale’, incompatibile con la sharia. Da questo punto di vista, l’informazione deve essere ‘educativa’ e ‘moralmente corretta’, conforme alla dottrina islamica nella versione deobandi che i talebani professano e impongono con la forza.
Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, già esistente nel primo regime (1996–2001) e ulteriormene rinvigorito nel Secondo Emirato, ha assunto il controllo dell’intero sistema mediatico. Pertanto, ciascuna redazione deve essere registrata, i contenuti devono essere approvati, e le violazioni sono punite con arresti, torture o chiusure forzate; dal 2021, poi, sono anche vietate la musica, l’immagine femminile, la critica ai leader religiosi e qualsiasi riferimento all’ex-governo repubblicano, in una riscrittura della storia e dell’immaginario collettivo.
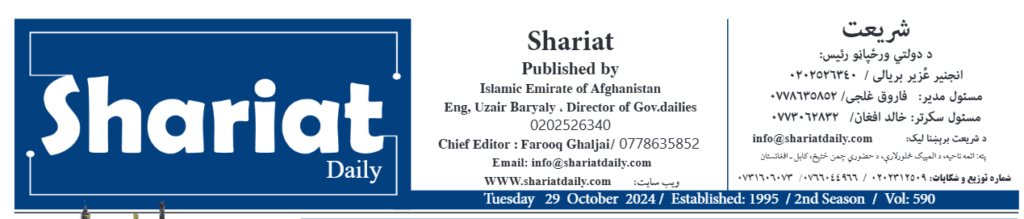
In questa cornice, i media afghani si sono ridotti a organi di comunicazione governativa, come dimostra Bakhtar News Agency, rinata come agenzia di Stato, che diffonde comunicati ufficiali e cronache religiose; i quotidiani storici, come Anis, Hewad, The Kabul Times, sono diventati strumenti di propaganda, simili alle pubblicazioni dei regimi autoritari del secolo scorso. Anche le televisioni locali, in passato vivaci e pluraliste, sono state purgate dei programmi culturali e musicali, sostituiti da sermoni e trasmissioni ‘educative’.
Non si tratta solamente di censura, ma di una precisa strategia di sacralizzazione del linguaggio, in cui l’informazione viene reinterpretata come dawa, predicazione e proselitismo islamico, mentre il giornalista diventa ‘servo della verità divina’. Il risultato è una totale (e voluta) confusione e sovrapposizione tra notizia e dogma, tra cronaca e dottrina islamica; il linguaggio pubblico (ufficiale) non descrive più la realtà, ma la sostituisce, riscrivendola.
La Rimozione delle Donne dallo Spazio Pubblico
Tra le vittime di questa restaurazione, le giornaliste rappresentano il volto più visibile della repressione, in quanto, durante l’era repubblicana, erano diverse le donne che (con fatica e sfidando i tabù sociali ancora esistenti) avevano conquistato posizioni di rilievo nei media. Alcune di esse conducevano programmi televisivi, altre dirigevano testate, altre ancora raccontavano con coraggio le violenze domestiche e le discriminazioni sociali; attualmente, queste voci alternative sono state ridotte al silenzio.

Le nuove direttive proibiscono alle donne di apparire in video senza il volto coperto, di intervistare uomini, o di viaggiare senza un accompagnatore; in numerose province, il semplice fatto di lavorare in una redazione è considerato sconveniente. Per queste ragioni, molte giornaliste hanno scelto l’esilio, altre si nascondono, mentre altre ancora sono state arrestate o intimidite; il caso di Rukhshana Media, fondato da un gruppo di giornaliste fuggite in Europa, è emblematico. La testata, nata in era repubblicana, ha dovuto scegliere l’esilio a Londra per sopravvivere e continuare ad operare.
Un articolo di 8am daily, testata che opera online, ricorda che
On Sunday, December 12, 2021, the Afghan Journalists Safety Committee (AJSC) announced that the Taliban had banned the broadcasting of female voices in the provinces of Balkh, Takhar, and Jawzjan. According to the committee, the Taliban imposed similar restrictions on the attire of female journalists, the airing of serials, films, and advertisements in these provinces, as well as in Ghor province.
The Taliban also banned the broadcasting of female voices in Kandahar province, including cooking and religious programs. The Taliban’s Information and Culture Directorate in this province ordered media outlets to avoid contacting women or inviting them to their programs. This decision was made during a local Taliban officials’ meeting on Wednesday, December 28, 2022, in Kandahar.
Taliban intelligence officials in Kandahar province conveyed the group’s restrictions to several journalists in a meeting. Hamim Arslan, head of the Taliban’s Intelligence Media Office, stated during that meeting that the media should prepare to stop employing women and reduce the need for female employees. In the presence of officials from the Ministries for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice, Hajj and Religious Affairs, Higher Education, Information and Culture, and the police command, Arslan verbally communicated eleven points that media outlets were required to implement.
According to this directive, women are prohibited from making phone calls to radio and television programs. Offices for men and women in media outlets must be separated, and female employees must adhere to the group’s dress code.
Domenica 12 dicembre 2021, il Comitato per la Sicurezza dei Giornalisti Afghani (AJSC) ha annunciato che i talebani avevano vietato la trasmissione di voci femminili nelle province di Balkh, Takhar e Jawzjan. Secondo il comitato, i talebani hanno imposto restrizioni simili all’abbigliamento delle giornaliste, alla trasmissione di serie, film e pubblicità in queste province, così come nella provincia di Ghor.
I talebani hanno anche vietato la trasmissione di voci femminili nella provincia di Kandahar, inclusi programmi di cucina e religiosi. La Direzione dell’Informazione e della Cultura dei talebani in questa provincia ha ordinato ai media di evitare di contattare le donne o di invitarle ai loro programmi. Questa decisione è stata presa durante una riunione dei funzionari locali talebani mercoledì 28 dicembre 2022 a Kandahar.
Funzionari dell’intelligence talebana nella provincia di Kandahar hanno comunicato le restrizioni del gruppo a diversi giornalisti durante un incontro. Hamim Arslan, capo dell’Ufficio Stampa dell’Intelligence dei Talebani, ha dichiarato durante quell’incontro che i media dovrebbero prepararsi a smettere di impiegare donne e a ridurre la necessità di dipendenti di sesso femminile. Alla presenza di funzionari dei Ministeri per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, degli Affari Hajj e Religiosi, dell’Istruzione Superiore, dell’Informazione e della Cultura, e del comando di polizia, Arslan ha comunicato verbalmente undici punti che i media erano tenuti ad attuare.
Secondo questa direttiva, alle donne è vietato fare telefonate a programmi radiofonici e televisivi. Gli uffici per uomini e donne nei media devono essere separati e le dipendenti devono attenersi al codice di abbigliamento del gruppo.
Amin kawa, Taliban’s Push to Erase Women from Media: Complete Ban on Female Voices and Images in Sight, 19 August, 2024.
La soppressione della parola femminile ha un valore simbolico profondo e politico, e non si riduce a ‘semplice’ misoginia; la censura delle voci femminili ha un profondo impatto sulla società; significa ridurre il pluralismo ad un monologo monocorde, quello del potere religioso. In Afghanistan, la censura di genere è dunque il cuore stesso del controllo ideologico di istituzioni che si basano sull’imposizione di una narrazione a senso unico e non negoziabile.
La Diaspora come Nuova Sfera Pubblica
Mentre il Paese sprofonda nel silenzio, fuori dai suoi confini nasce un Afghanistan differente, virtuale, pluralista e critico del nuovo regime, grazie alla libertà concessa in Europa e in Occidente; la diaspora giornalistica afghana è attualmente una delle più attive e coese del mondo islamico.
Molti giornalisti fuggiti nel 2021 hanno fondato nuove redazioni in esilio, cone Etilaatroz, giornale investigativo fondato nel 2010 a Kabul, che continua a pubblicare articoli che denunciano la corruzione del regime e le violazioni dei diritti umani. 8am Daily (Hasht-e Subh), esiliato in Canada e Germania, mantiene una fitta rete di informatori nel Paese, diffondendo notizie quotidiane in dari e pashto; ancora, Zan Times e Rukhshana Media documentano la condizione delle donne. Infine, Amu TV e Afghanistan International trasmettono via satellite notiziari e dibattiti, mentre Afghan Witness verifica e archivia prove di crimini di guerra, collaborando con ONG e tribunali internazionali.
Queste testate formano un ecosistema mediatico diffuso, in cui la distanza geografica diventa garanzia di libertà; tali media operano in diverse lingue (dari, pashto, inglese) e si rivolgono sia alla diaspora sia al pubblico interno, che accede ai contenuti tramite VPN, canali Telegram o reti satellitari clandestine. In questo modo, la parola proibita ritorna in patria attraverso le fibre ottiche, sfidando la censura con l’arma più sottile, la connessione.
Il Giornalismo in Esilio come Resistenza Politica
Le redazioni in diaspora non si limitano ad informare, ma esprimono una forma efficacia di resistenza al potere talebano; la loro funzione è allo stesso tempo culturale, politica e morale, mediante la documentazione di violenze e abusi. Inoltre, esse preservano l’idea stessa di cittadinanza, di una società capace di parlare e di pensarsi in termini razionali.
Il linguaggio di queste testate esprime la tensione tra due identità, quella nazionale, radicata nella lingua e nella memoria afghana, e quella cosmopolita, forgiata nel contatto con i valori democratici occidentali. Questa ambivalenza produce un discorso ibrido, che unisce indignazione morale e rigore giornalistico, compassione e analisi. In un certo senso, i giornali della diaspora non raccontano solo l’Afghanistan, ma raccontano anche la propria nostalgia, di un Paese che non può più ascoltare se stesso.
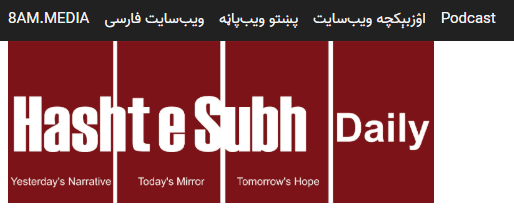
Il loro ruolo politico è fondamentale, in assenza di partiti, di opposizione e di istituzioni libere, i media in esilio sono diventati l’unica arena pubblica dove si discute il futuro del Paese; le loro inchieste influenzano i dibattiti nei parlamenti europei, alimentano le campagne delle ONG e offrono testimonianze dirette alle Nazioni Unite. Di fatto, essi sono divenuti una forma di diplomazia civile, una voce alternativa che parla al mondo in nome di chi non può più farlo.
L’Informazione Clandestina e il Nuovo Spazio Digitale
Nonostante la brutalità della censura, all’interno dell’Afghanistan sopravvivono forme di giornalismo sotterraneo; giovani reporter e cittadini comuni continuano a filmare, scrivere, documentare in segreto; attraverso reti anonime e piattaforme criptate, essi inviano materiali alle testate in esilio, rischiando la propria vita.
In questo nuovo scenario, il giornalismo non è più una professione riconosciuta, ma un atto di coraggio individuale; la distinzione tra reporter e testimone si dissolve, e chi racconta, filma, e condivide un video sui social diventa parte di un giornalismo diffuso, fragile ma resistente. Si tratta di una forma di comunicazione che non ha redazioni né tipografie, ma vive nella connessione tra individui che si rifiutano di accettare il silenzio e la censura.
Questa dimensione digitale ha cambiato la natura stessa del giornalismo afghano, e se in passato il giornalista era un mediatore tra il potere e la società, atttualmente egli è un ponte tra il reale e l’esilio, tra il vissuto quotidiano e la memoria globale. Un testimone senza patria, ma con una voce che attraversa confini e censura, per raccontare il Paese reale, lontano dalle violenze e dai giochi politici dei talebani.
Dal punto di vista geopolitico, il conflitto mediatico tra i talebani e la diaspora è un conflitto tra due immagini dell’Afghanistan; all’interno, il regime costruisce la propria narrazione di ordine e purezza, raccontando un Paese devoto, pacificato, moralmente rigenerato. All’esterno, la stampa in esilio propone l’immagine opposta, ma reale, quella di un Paese oppresso, prigioniero del fondamentalismo e isolato dal mondo.
Conclusione – La Parola come Forma di Sopravvivenza
L’evoluzione del giornalismo afghano, dal fragile e incerto pluralismo della Repubblica al silenzio imposto dell’Emirato, evidenzia la storia di un popolo che ha intravvisto la libertà, e ne conserva il ricordo come una ferita aperta. È la storia di una parola che, bandita dalle piazze di Kabul, continua a circolare nei satelliti, nei blog, nei podcast della diaspora, nei messaggi criptati di chi non si arrende.
Il potere talebano può controllare le redazioni, ma non può dominare completamente il linguaggio, in quanto ogni sistema autoritario ha bisogno di una narrazione coerente, e la realtà, per sua natura, non lo è mai. Il giornalismo, anche ridotto all’esilio, continua a incrinare quella coerenza, mostrando la discrepanza tra l’ordine proclamato e la vita reale, aiutato dai social media e dalle leggi occidentali, che permettono di rendere concreta la libertà di informazione.
In ultima analisi, è ragionevole ritenere che la libertà di stampa in Afghanistan non sia scomparsa, ma si è trasformata, ed è divenuta transnazionale, digitale, diffusa, precaria ma indomita; essa continua a vivere nelle parole di chi scrive da Berlino o da Toronto, ma anche nei silenzi ostinati di chi resta a Kabul e, pur non potendo parlare, ascolta. In questa tensione tra voce e silenzio, tra verità e paura, si gioca oggi il destino morale di un Paese che continua a cercare, nella parola, la propria sopravvivenza.
Letture Consigliate
- Kakar, H. (2022). Women, Media, and Power in Post-2001 Afghanistan. Asian Affairs, 53(2), 314–332.
- Lowe, T. (2023). Digital Witnessing and Remote Journalism: Afghan Media in the Age of Diasporic Networks. International Journal of Communication, 17, 2850–2873.
- Siddiqi, F. (2023). The Gendered Erasure of Journalistic Space in Taliban-Controlled Afghanistan. Media, Culture & Society, 45(6), 1251–1270.

