Abstract
Il romanzo Batavia di Hendrik Conscience, pubblicato per la prima volta nel 1858 e riproposto nel 1912 all’interno delle Volledige Werken, rappresenta un tassello singolare nel panorama della letteratura coloniale europea. Pur essendo frutto dell’immaginazione di un autore che non ebbe mai esperienza diretta delle Indie orientali, l’opera rielabora in chiave romantica ed eroica la fondazione della capitale giavanese della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, inscrivendosi in quella tradizione di narrazioni esotiche che alimentarono l’immaginario imperiale. Collocato cronologicamente tra le descrizioni erudite di François Valentijn nel Settecento e la denuncia radicale di Multatuli in Max Havelaar (1860), Batavia testimonia la persistenza, a metà Ottocento, di un discorso letterario che celebrava l’impresa coloniale come mito fondativo, mentre nuove voci iniziavano a mettere in luce le contraddizioni di questo modello.
Hendrik Conscience’s novel, Batavia, first published in 1858 and reissued in 1912 as part of his Complete Works, is a unique piece in the landscape of European colonial literature. Although it is the product of the imagination of an author who never had direct experience of the East Indies, the work reinterprets the founding of the Javanese capital of the Dutch East India Company in a romantic and heroic key, fitting into the tradition of exotic narratives that fuelled the imperial imagination. Chronologically situated between François Valentijn’s erudite descriptions in the 18th century and Multatuli’s radical denunciation in Max Havelaar (1860), Batavia testifies to the persistence, in the mid-19th century, of a literary discourse that celebrated the colonial enterprise as a founding myth, while new voices began to highlight the contradictions of this model.
Introduzione – La Batavia Immaginata
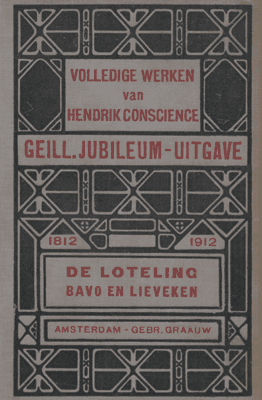
Quando nel 1912 apparve il primo volume delle Volledige Werken di Hendrik Conscience, intitolato Batavia, il pubblico fiammingo ed europeo poteva già considerare l’autore come un classico nazionale. Conscience era nato ad Anversa nel 1812 e morto nel 1883, ed era diventato noto come il ‘padre della letteratura fiamminga moderna’, un romanziere che aveva dato dignità letteraria alla lingua neerlandese in Belgio, che fino ad allora era stata percepita come secondaria rispetto al francese. La pubblicazione delle opere complete rappresentava dunque una sorta di consacrazione postuma, ma offriva anche l’occasione per riprendere testi meno noti, come appunto Batavia, e collocarli in un quadro più ampio, quello della letteratura coloniale europea.
Il romanzo, pur non avendo la fama di altre opere da lui composte, come De Leeuw van Vlaanderen, Il Leone delle Fiandre, del 1838, possiede una sua forza evocativa, e racconta la fondazione della città di Batavia, la futura Giacarta, nel XVII secolo, attraverso la vicenda eroica e romanzata di un giovane avventuriero. In questo intreccio di storia e finzione, di esotismo e moralismo, si può cogliere non solamente lo stile narrativo di Conscience, ma anche l’immaginario coloniale che percorse l’Europa per secoli, e che, in una certa misura, rimane immutato.
Conscience e la Vocazione al Romanzo Storico
Per comprendere Batavia bisogna partire dal profilo dell’autore, in quanto Conscience era un uomo dell’Ottocento, impregnato di romanticismo e di spirito nazionale; insieme a De Leeuw van Vlaanderen egli aveva celebrato le antiche lotte dei fiamminghi contro i francesi, trasformando la storia medievale in un’epopea popolare. La sua scrittura non puntava alla precisione filologica o storica, ma all’efficacia emotiva, grazie agli eroi idealizzati e alle ambientazioni pittoresche, a cui si aggiungono le trame tese a trasmettere valori morali e patriottici.
Da questo punto di vista, Batavia si inserisce perfettamente nella sua produzione lettraria, e la scelta di un episodio della storia coloniale olandese non deve essere considerata come l’adesione ad un progetto politico oppure una testimonianza di viaggio. Si tratta di generi storici e politici, di cui si trova ampia testimonianza nella produzione olandese a partire dal XVII secolo; al contrari di viaggiatori ed esploratori, che spesso appartenevano all’apparato militare o erano funzionari coloniali o missionari, Conscience non mise mai piede in Asia. Per questa ragione, la scelta della tematica coloniale offre un’occasione narrativa e letteraria, la lontananza temporale (l’opera viene pubblicata per la prima volta nel 1858, mentre la Batavia narrata è del XVII secolo) e geografica (l’autore vive in Belgio, mentre il romanzo si svolge nelle Indie Orientali Olandesi) gli consentiva di proiettare le vicende in un passato remoto e in un orizzonte esotico. In questo modo, egli ebbe l’occasione di affrontare tematiche considerate importanti, come il coraggio, il sacrificio e la fondazione di comunità solide e disciplinate.
Trama e Ambientazione
Il romanzo si apre con immagini potenti ed evocative, ovvero il porto di Amsterdam, gremito di navi, carichi e marinai, con il giovane Walter Pietersen che si prepara a salpare verso l’ignoto; pertanto, il tono eroico ed epico del romanzo emerge dal suo inizio. La partenza diventa un rito di iniziazione, con la madre malata che benedice il figlio, ed il mare che viene assunto come spazio di prova e di avventura.
Nel romanzo, in effetti, la madre si rivolge al figlio con queste parole,
“Il tuo temperamento è troppo acceso. L’uomo deve, fin dalla giovinezza, abituarsi alle tribolazioni. La vita non è che una prova, figliolo; oltre a questo, riceviamo la ricompensa della nostra pazienza nella sofferenza.”
(Hendrick Conscience, Volledige werken 1. Batavia., Opere Complete 1. Batavia, J. Lebègue, Brussel, 1912, p. 10)
Arrivato a Giava, Walter diventa testimone e attore della costruzione di Batavia, la città-fortezza che Jan Pieterszoon Coen aveva voluto edificare sulle rovine di Jacatra, l’antico insediamento indigeno; Conscience descrive con gusto quasi pittorico il fervore del cantiere, rappresentando le mura possenti che si innalzano, i magazzini colmi di merci, i moli affollati di imbarcazioni. Accanto agli olandesi si muove una folla variegata, composta da cinesi, schiavi africani, e mercenari di varia provenienza, tutti impegnati a dare forma a quella che sarebbe diventata il cuore pulsante della presenza europea nell’Asia Sud-Orientale.
Il romanzo si sviluppa tra battaglie, assalti notturni e minacce di ribellioni, mentre il grido ‘Batavia!’ che risuona nelle pagine diventa un potente simbolo, in quanto non si tratta solamente del nome di una città, ma la parola d’ordine di una civiltà che si afferma contro le insidie dell’ambiente e dell’altro, un’alterità percepita come caotica e minacciosa, da sottomettere e civilizzare. Il lettore è dunque condotto in una trama di pericoli e di sacrifici, sempre con la consapevolezza che il destino dei protagonisti coincide con quello della comunità europea in Oriente. Viene dunque narrata una missione, non un semplice viaggio o spedizione, la missione civilizzatrice degil olandesi, che sottomettono e trasformano una società percepita come caotica in una ordinata e civilizzata.
La Funzione del Mito
È evidente che la Batavia di Conscience non coincide con la Batavia reale, che, nel Seicento fu teatro di carestie ed epidemie; la narrazione, in effetti, non riflette gli aspetti negativi, ma solamente gli intenti dichiarati, e crea immagini epiche e luminose.
Questa rappresentazione selettiva della realtà nel racconto non è un limite, ma piuttosto la chiave per comprendere il romanzo, che non ha l’intento di ricostruire eventi storici o di criticare la società e/o il modello coloniale. Batavia, dunque, non vuole documentare, ma presentare aspetti parziali, allo scopo di costruire una sorta di ‘mito delle origini’; in tale contesto, la città diventa il simbolo della missione civilizzatrice europea, il teatro di un’epopea collettiva. La sofferenza dei protagonisti, i pericoli affrontati, i sacrifici compiuti sono elementi di una narrazione provvidenzialistica, in cui l’Europa porta ordine dove regnavano caos e violenza, e costruisce città dove in precedenza dominavano foreste e paludi.
In tal senso, il romanzo si inserisce nella più ampia tradizione della letteratura coloniale, che non si limita a raccontare terre lontane, ma contribuisce a costruire un immaginario, quello di un Oriente pittoresco e minaccioso, destinato a essere dominato e ordinato dalla razionalità occidentale.
Confronto con altre Opere Coloniali
Per collocare Batavia nel panorama della letteratura coloniale olandese, occorre ricordare altri testi chiave che si possono ricomprendere nello stesso genere o in generi affini; nel Settecento, autori come François Valentijn avevano pubblicato opere semi-documentarie come Oud en Nieuw Oost-Indiën, che combinavano tra loro osservazioni etnografiche e resoconti di viaggio. Nell’Ottocento, Multatuli con Max Havelaar (1860) aveva infranto l’immagine idilliaca delle Indie, denunciando le ingiustizie del sistema coloniale e denunciando la corruzione dei funzionari olandesi e dei loro collaboratori.
Conscience non appartiene a nessuno dei due filoni, in quanto egli non è un osservatore diretto, come Valentijn, ma nemmeno un critico, come Multatuli; egli, piuttosto, è un romanziere che utilizza il materiale coloniale come sfondo per una narrazione di ampio respiro. In questo senso, Batavia è maggiormente assimilabile ad alcune avventure coloniali francesi o inglesi, dove l’esotismo non è strumento di denuncia, ma una cornice suggestiva in cui si inseriscono vicende di eroismo e sacrificio per la madrepatria.
Tematiche e Simboli Ricorrenti
Il romanzo si regge su alcuni nuclei simbolici che meritano di essere sottolineati, a partire dalla città, che diventa una creazione civilizzatrice; per questa ragione, Batavia non si può considerare un semplice luogo, ma un progetto vero e proprio. Quest’ultimo, poi, contempla la trasformazione della natura selvaggia in ordine urbano, allo scopo di imprimere sull’Asia il marchio dell’Europa.
Il giovane eroe diventa una figura esemplare, e Walter Pietersen, in effetti, diventa l’incarnazione dell’avventuriero che, attraverso prove e sacrifici, diventa degno di rappresentare la comunità e di portare la civiltà in Asia. Un altro tema fondamentale, ancora, è costituito dal sacrificio collettivo, e, in effetti, la costruzione della città non è opera di singoli, ma piuttosto il risultato dell’impegno comune, in cui emerge come protagonista l’intera comunità europea, ovvero l’Occidente.
Da ultimo, si consideri il tema dell’esotismo funzionale, che considera l’altro, rappresentato dai diversi gruppi etnici presenti nelle Indie Orientali Olandesi, come cinesi e giavanesi, non come soggetti autonomi, ma come semplici comparse che servono a definire il ruolo centrale degli olandesi.
Questi elementi collocano il testo nell’ambito della retorica coloniale ottocentesca, che presentava l’Europa come soggetto attivo e civilizzatore, mentre le popolazioni locali erano rappresentate come secodarie o come una minaccia per l’ordine occidentale.
Ricezione e Attualità
Al momento della pubblicazione delle Volledige Werken (Opere Complete), Conscience era già considerato patrimonio nazionale; anche se Batavia non divenne un testo scolastico come De Leeuw van Vlaanderen, esso rimase parte integrante del corpus di un autore che aveva saputo conferire una certa dignità letteraria alla lingua neerlandese.
Attualmente, questo romanzo possiede una valenza differente rispetto allo scopo per il quale era stato creato; si tratta, in effetti, di un documento prezioso per studiare il modo in cui il colonialismo veniva rappresentato, immaginato e giustificato. A tale proposito, si ricorda la valenza anche religiosa della missione civilizzatrice, come emerge dalle parole pronunciate dal protagonista del romanzo,
Lo sfortunato bambino moro mi è diventato caro perché sono riuscito a instillare il concetto del Divino nella sua anima ignorante; perché sono stato io a renderlo cristiano, perché in lui sono riuscito a proteggere un essere umano dall’ingiustizia umana…
(Hendrick Conscience, Volledige werken 1. Batavia., Opere Complete 1. Batavia, J. Lebègue, Brussel, 1912, p. 10)
Batavia si colloca in una posizione ben diversa dall’analisi critica di Multatuli, ma anche dal rigore descrittivo dei cronisti, e mostra gli aspetti più immaginifici del mito coloniale, che però si basano su elementi presi dalla realtà. La qualifica di romanzo ‘patriottico’ e ‘coloniale’, in altre parole, non si traduce in pura invenzione. Per questa ragione, questo genere di letteratura è riuscita a radicare nell’opinione pubblica europea l’idea di una missione civilizzatrice necessaria, anche dal punto di vista religioso, e non solamente politico o sociale.
Conclusione
Batavia di Hendrik Conscience è un’opera letteraria che trasforma la fondazione della città di Batavia in un mito eroico, in cui si riflette il progetto civilizzatore europeo, e non la realtà, rappresentata parzialmente e indirettamente. Si tratta comunque di un romanzo che, nell’ambito della letteratura coloniale olandese occupa una posizione marginale ma significativa. Si tratta della voce di un autore fiammingo che, senza nessuna esperienza diretta delle Indie, partecipa comunque alla costruzione di quell’immaginario che giustificava e celebrava l’espansione coloniale. Attualmente, il valore principale del romanzo risiede nella testimonianza di questa concezione del colonialismo, che era attivamente sostenuta da una parte della società.
Del resto, le gesta del protagonista non appaiono diverse, da un punto di vista qualitativo ad episodi evocativi della presenza ed espansione coloniale britannica in India; il fil rouge, in effetti, è la dicotomia tra la civiltà, rappresentata dall’Occidente, dall’Europa, e dal caos e dall’ingiustizia, rappresentati dall’Oriente, anche nella sua componente religiosa, l’Islam, chiamato Maomettismo.
Per questa ragione, leggere Batavia significa riappropriarsi di un elemento fondamentale della civiltà occidentale, che spesso viene deformato per ragioni di convenienza politica, ma che di fatto ha posto le premesse per la società odierna.
Letture Consigliate
- Huigen, S. (2022). Het lange leven van François Valentijns Oud en Nieuw Oost-Indiën in de negentiende eeuw. Internationale Neerlandistiek, 60(2), 129–148.
- Huigen, S. (2021). Het gebruik van “Oud en Nieuw Oost-Indiën” van François Valentijn door bewindhebbers van de VOC in de achttiende eeuw. Neerlandica Wratislaviensia, 32, 137–156.
- Hellwig, T. (2002). Scandals, Homicide in Batavia and Indo Identity: Literary Representations of Indies Society. Archipel, 63, 153–172.

