Yazid Jawas è uno degli esponenti più noti del salafismo indonesiano, a ragione della sua predicazione divisiva e derogatoria; egli si presenta come uno dei ‘purificatori’ della fede islamica; tuttavia, il risultato è quello di fomentare sospetti e divisioni sia tra i musulmani che rispetto a coloro che professano altre fedi religiose. Per queste ragioni, egli risulta controverso nel suo stesso Paese, e la maggioranza dei sapienti islamici non accetta il suo discorso aggressivo e divisivo, privo della saggezza derivante da secoli di integrazione tra alcune pratiche tradizionali e l’Islam.
Yazid Jawas is one of the most well-known Salafi preachers in Indonesia, due to his divisive and deviant preaching; He presents himself as one of the ‘purifiers’ of the Islamic faith; However, the result is to fuel suspicion and division both among Muslims and towards those who profess other religious faiths. For these reasons, he is controversial in his own country, and the majority of Islamic scholars do not accept his aggressive and divisive discourse, which lacks the wisdom derived from centuries of integration between some traditional practices and Islam.
Introduzione – Una Figura Divisiva
La figura di Yazid bin Abdul Qadir Jawas rappresenta una delle voci più riconoscibili del salafismo indonesiano contemporaneo; si tratta di un predicatore prolifico, autore di testi molto diffusi e punto di riferimento per una parte consistente (ma sempre marginale) di musulmani. Jawas incarna quel ramo del salafismo che, pur non assumendo una postura apertamente jihadista o militante, contribuisce a definire un immaginario rigido, esclusivo e divisivo. La sua predicazione, apparentemente concentrata sulla purezza dottrinale, finisce per avere conseguenze che travalicano il piano strettamente religioso, alimentando un clima di diffidenza e contrapposizione che incide sulle dinamiche interne all’Islam indonesiano e, più in generale, sul delicato equilibrio pluralista del Paese.
Jawas rappresenta, dunque, una figura polarizzante e divisiva, che non risulta compatibile con la vita di uno stato moderno e plurale come l’Indonesia; la sua predicazione, e soprattutto i suoi scritti, alimentano un clima di odio e sospetto, pericolosamente contiguo per la radicalizzazione violenta.
Biografia e Formazione Religiosa
Nato nel 1962 a Karawang nella provincia di Giava Occidentale (e morto nel luglio del 2024), Jawas ha intrapreso studi religiosi che lo hanno condotto in Arabia Saudita, a Medina, uno dei principali centri di diffusione del salafismo globale, al pari di altri predicatori indonesiani (e non). È in tale contesto che egli ha assimilato l’approccio purista della corrente wahhabita, fondata su una adesione rigorista alla dottrina del tawhid, interpretata, ovviamente, secondo i canoni salafiti, oltre che sulla lotta incessante (e ossessiva) contro ciò che viene percepito come deviazione (bidʿah). Tornato in Indonesia, ha avviato un’intensa attività di predicazione e di pubblicazione, fondando scuole e centri di formazione che hanno progressivamente consolidato la sua influenza.
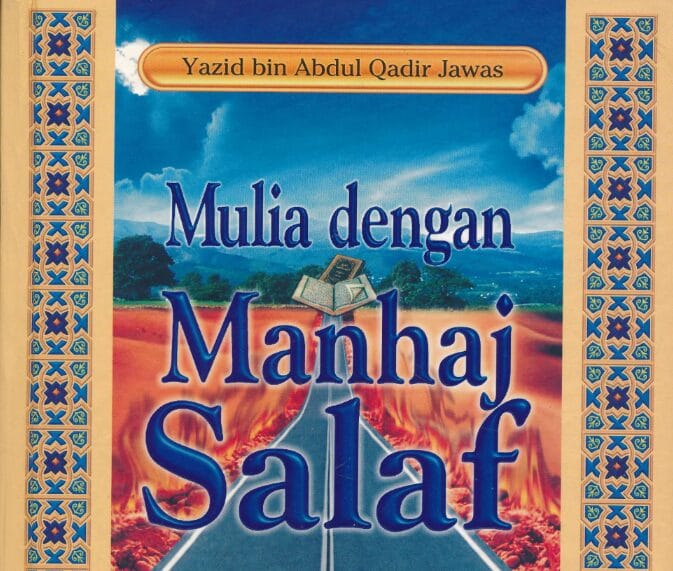
La sua opera più nota, Mulia dengan Manhaj Salaf (La nobiltà del manhaj salaf), è diventata una sorta di manuale di riferimento per i suoi seguaci, diffuso in scuole, moschee e ambienti associativi. A questo si affianca una vasta produzione di opuscoli, sermoni registrati e materiali diffusi tramite internet, che gli hanno garantito un pubblico molto vasto.
La Centralità del Manhaj Salaf
Il cuore della predicazione di Jawas è l’esaltazione del cosiddetto manhaj salaf, il (supposto) metodo di vita e di fede dei ‘pii antenati’ (al-salaf al-salih), le prime tre generazioni di musulmani; la sua interpretazione si traduce in un approccio rigidamente letterale alle fonti islamiche (il Corano e la Sunna) e in un rifiuto netto di qualunque innovazione successiva. In tale prospettiva, l’Islam autentico sarebbe stato contaminato da secoli di pratiche popolari, tradizioni locali e interpretazioni giuridiche pluralistiche che ovviamente bisognerebbe abbandonare, anche quando si tratta di pratiche consolidate nella tradizione culturale indonesiana.

Jawas si propone dunque come una sorta di ‘restauratore’ della purezza originaria, ma tale restaurazione non avviene in termini neutri; al contrario, il linguaggio usato è fortemente polemico, offensivo, e spesso impregnato di connotazioni derogatorie verso chiunque non si conformi alla sua visione. In questo senso, il suo contributo non è solo teologico, ma anche (e soprattutto) sociale e politico, in quanto egli crea volutamente una frattura permanente tra un ristretto gruppo di ‘veri musulmani’ (quelli che seguono la sua predicazione) e la massa dei credenti accusati sommariamente di deviazione.
Linguaggio Polemico e Visione Totalizzante
Una delle caratteristiche più evidenti della produzione di Jawas è la sistematicità con cui attacca categorie differenti di musulmani e non musulmani, allo scopo di ‘dimostrare’ la loro deviazione, mediante una lettura artefatta e rigorista dei testi sacri islamici.
I bersagli della sua retorica, del resto, sono molteplici:
- I musulmani tradizionali della Nahdlatul Ulama, che vengono bollati come superstiziosi e contaminati da pratiche idolatriche.
- I sufi, con le loro confraternite e rituali, considerati introduttori di innovazioni eretiche.
- I riformisti del Muhammadiyah, vicini in parte al purismo religioso, vengono accusati di compromesso e di non seguire pienamente il metodo salafita.
- I non musulmani sono trattati come una minaccia costante, oggetto di diffidenza e ostilità.
- Infine, persino altri predicatori salafiti vengono talvolta delegittimati come insufficientemente coerenti.
Questa moltiplicazione di nemici produce un universo discorsivo in cui (quasi) nessuno sfugge al sospetto; il risultato è la costruzione di un sistema binario e totalizzante, formato da due gruppi ideali e contrapposti. Da un lato, i pochi che aderiscono integralmente al manhaj salaf, dall’altro una massa di deviati e infedeli, accusati in maniera gratuita e pretestuosa, alimentando la polemica e la visione del mondo proposta, secondo un modello ben consolidato.
Quietismo Apparente e Implicazioni Politiche
A differenza dei gruppi jihadisti, Jawas non incita apertamente alla lotta armata né alla ribellione contro lo Stato indonesiano. La sua posizione si inserisce in quella corrente del salafismo definita “quietista”, che invita i fedeli a concentrarsi sulla purificazione interiore e sulla corretta pratica religiosa. Tuttavia, questo quietismo è solo apparente.
Dietro la facciata di neutralità politica, Jawas costruisce una visione che ha conseguenze fortemente destabilizzanti:
- Delegittimazione dello Stato pluralista – pur senza chiamare all’insurrezione, egli presenta il sistema indonesiano, fondato sul Pancasila, come inevitabilmente contaminato da pratiche non islamiche.
- Erosione delle autorità religiose tradizionali – gli ulama di NU e Muhammadiyah, che da decenni fungono da mediatori tra Islam e politica, vengono screditati come portatori di innovazioni.
- Riduzione dello spazio del compromesso – la sua predicazione alimenta l’idea che qualunque forma di dialogo interreligioso o di coesistenza con i non musulmani equivalga a una capitolazione.
In questo modo, pur senza agire direttamente nel campo politico, Jawas contribuisce a creare un immaginario che mina le basi stesse della convivenza pluralista, coerentemente con la dottrina da lui professata.
Nella sua opera principale, del resto, la parola ‘politik’, politica, ricorre ben 59 volte, mentre il vocabolo ‘bodoh’, ‘ignorante’, ‘ignoranza’, ricorre per 34 volte; su un totale di circa 500 pagine, si tratta di una frequenza significativa, che raramente si riscontra in opere ufficiali. Tale frequenza di termini derogatori denota il carattere polemico del testo e della predicazione di Jawas, che non è possibile fraintendere; il predicatore costruisce un discorso articolato, incentrato nei concetti diametralmente opposti di ‘purezza’ e di ‘ignoranza’.
Differenze con i Salafiti Jihadisti e Politicizzati
Sembra utile, a questo punto, confrontare la sua posizione con quella di altri esponenti salafiti indonesiani; da un lato, vi sono figure jihadiste come Abu Bakar Baasyir, fondatore di Jemaah Islamiyah, che hanno teorizzato e praticato la violenza come strumento politico. Dall’altro, vi sono attori che hanno cercato di inserire il salafismo nella dinamica partitica, pur con scarsi risultati, sostenendo movimenti islamisti nelle competizioni elettorali.
Jawas si colloca in una terza posizione, in quanto egli non partecipa direttamente alla politica, ma cerca di influenzarne i presupposti culturali; se Baasyir costruisce l’organizzazione militante e il militante politico si candida alle elezioni, Jawas lavora a monte, cercando di plasmare le coscienze con una narrazione che normalizza il sospetto e la contrapposizione. Questa funzione indiretta è forse più pervasiva, perché si radica nella quotidianità dei fedeli e nelle istituzioni educative, e viene percepita come ‘normale’; si è ben lontani, in effetti, dall’allarme sociale destato da attori politici o jihadisti. L’opera di Jawas, tuttavia, a ragione della sua diffusione capillare grazie ai social media, rischia di avere effetti devastanti, in termini di radicalizzazione, anche violenta.
Impatto e Critiche
L’effetto più rilevante della predicazione di Jawas non si misura tanto nella militanza politica immediata, quanto nelle trasformazioni sottili che introduce nel tessuto sociale; la diffusione delle sue opere nelle scuole religiose (pesantren), nelle moschee e online contribuisce a rafforzare una cultura della divisione (apartheid), del sospetto e del controllo.
Molti giovani cresciuti ascoltando le sue lezioni interiorizzano un Islam di contrapposizione, nel quale il vicino che pratica riti tradizionali diventa un avversario e il compagno di classe cristiano o indù un potenziale nemico della fede. Questo clima, pur non traducendosi necessariamente in violenza fisica, crea una predisposizione a vedere la società come un campo di battaglia simbolico, mentre l’Islam viene concepito come una militanza continua. È in questo terreno che i messaggi jihadisti più radicali possono trovare terreno fertile, perché il sospetto generalizzato prepara la mente all’idea della lotta, anche violenta.
Questa dinamica presenta tratti che, pur in un contesto completamente diverso, possono essere accostati ai sistemi mafiosi, non già nella dimensione criminale ed economica, bensì nella capacità di esercitare controllo sociale attraverso l’intimidazione, la stigmatizzazione e la pressione morale. La violenza, in questo quadro, può essere verbale o simbolica, ma non per questo meno efficace nel plasmare comportamenti e mentalità. Non vi è prova che Jawas organizzi reti criminali o strutture paramilitari, ma il suo linguaggio e le implicazioni delle sue prediche finiscono per attivare dinamiche comunitarie simili a quelle proprie dei sistemi mafiosi, dove l’esclusione, l’isolamento e il sospetto diventano strumenti di disciplina.
Jawas non è, tuttavia, una figura universalmente accettata, anzi risulta decisamente controverso, e sono diversi i leaders di Nahdlatul Ulama e Muhammadiyah ad averlo criticato per l’eccessiva durezza del suo linguaggio e per la tendenza a spezzare l’unità della comunità musulmana indonesiana (umma). Alcuni intellettuali islamici hanno opportunamente sottolineato come il suo approccio tradisca la storia dell’Islam nel Sud-Est asiatico, caratterizzato da sincretismi e compromessi che hanno permesso la pacifica diffusione della religione.
Nonostante ciò, la sua popolarità dimostra che il richiamo alla purezza, soprattutto in tempi di incertezza sociale ed economica, mantiene una forza di attrazione notevole; quello da lui proposto è una sorta di totalitarismo religioso che non ammette critiche e nemmeno domande. Al contrario di quanto accade con altri predicatori salafiti (e.g. Khalid Basalamah), Jawas non accetta domande, ma si limita a proporre una serie di lezioni la cui validità non può essere discussa.
Conclusione
Yazid bin Abdul Qadir Jawas si presenta come un predicatore dedito alla restaurazione della fede autentica, del cosiddetto ‘puro Islam’; in realtà, la sua opera ha implicazioni molto più ampie, e la radicalità del suo linguaggio, l’uso costante di categorie derogatorie e l’ossessione per il sospetto producono un immaginario che non crea solamente divisioni tra gli stessi musulmani, ma compromette anche le possibilità di convivenza con le altre comunità religiose.
La sua visione politica, seppure non esplicitata in forma di programma, è tanto più insidiosa proprio perché sotterranea e subdola; essa mina alla radice la legittimità dello Stato pluralista senza assumersi la responsabilità di proporre alternative concrete. In questo modo, Jawas non è soltanto un teologo controverso, ma una figura che contribuisce a definire un clima culturale in cui la violenza (verbale o simbolica, ma potenzialmente anche fisica) diventa parte integrante dell’orizzonte quotidiano.
Letture Consigliate
- Andri, R. (2022). Deprived Muslims and Salafism: An ethnographic study of the Salafi movement in Pekanbaru, Indonesia. Religions, 13(10), 911.
- Hamdi, A. Z. (2023). The radicalization of contemporary educated Indonesian: A case study of university students in Yogyakarta. Kasetsart Journal of Social Sciences, 44(1), 155-162.
- Rahmi, D. K., & Sulhin, I. (2024). Radicalization and violent extremism of Indonesian children. Eduvest: Journal of Universal Studies, 4(5), 4196-4207.


[…] Il salafita teme continuamente di cadere e indurre altri all’errore, mentre per l’islam mainstream questo è un rischio accettabile, e in parte inevitabile per rimanere credibili e rilevanti nel contesto contemporaneo. Per questa ragione, nel salafismo, i trattati sistematici o gli interventi organici sono scoraggiati preventivamente, e solitamente riservati a sapienti considerati delle vere e proprie autorità dai salafiti indonesiani, come Jawas. […]