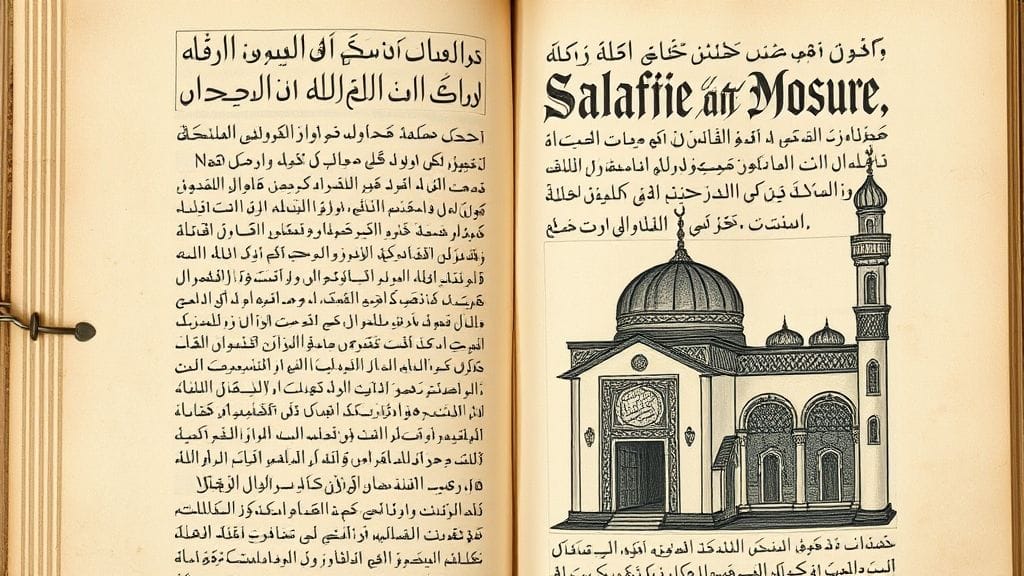L’ascesa dello Stato Islamico (ISIS/Daesh) a partire dal 2014 non ha rappresentato sol la creazione di una delle organizzazioni jihadiste più violente e mediaticamente efficaci della storia recente, ma ha innescato un impatto più ampio e per certi versi meno visibile, quello culturale e politico. L’eco del progetto di un califfato globale e l’uso strategico di immagini, simboli e narrazioni hanno generato una risposta profonda all’interno delle società contemporanee, che si è estesa oltre il perimetro geografico del Medio Oriente. Da un lato, ISIS ha ispirato militanza e imitazione in contesti locali, dall’altro ha contribuito ad alimentare paure, chiusure identitarie e derive securitarie che si sono tradotte in una più generale ondata conservatrice.
The rise of the Islamic State (ISIS/Daesh) since 2014 not only marked the creation of one of the most violent and media-effective jihadist organisations in recent history, but also triggered a broader and in some ways less visible impact: a cultural and political one. The echo of the project for a global caliphate and the strategic use of images, symbols, and narratives have generated a profound response within contemporary societies, extending beyond the geographical boundaries of the Middle East. On the one hand, ISIS has inspired militancy and imitation in local contexts, while on the other hand, it has contributed to fuelling fears, identity closures, and security-driven deviations that have translated into a more general conservative wave.
Introduzione – La Radicalizzazione Islamista
Il primo e più evidente effetto di ISIS è stato quello di attrarre individui e gruppi già predisposti alla radicalizzazione; migliaia di foreign fighters sono partiti dall’Europa, dall’Asia e perfino dal continente americano per unirsi al Califfato in Siria e Iraq. Questo fenomeno, di per sé inedito per le proporzioni e la rapidità, ha avuto (almeno) due conseguenze dirette; da una parte la creazione di reti transnazionali di militanza che hanno esportato il modello jihadista in Africa, in Asia centrale e nel Sud-est asiatico. Dall’altra, la percezione diffusa, nei paesi occidentali, di una minaccia interna difficilmente controllabile, e la necessità di creare una coalizione militare per combattere questa minaccia inedita.
Del resto, era stata proprio la propaganda dello Stato Islamico di Iraq e del Levante, mediante la sua prima pubblicazione multi-lingue, Dabiq, ad invitare i musulmani del mondo intero a fare ‘hijrah‘, ad ‘emigrare’ nelle terre del Califfato, presentando questa azione come obbligo religioso.
Nel numero 3 di Dabiq si possono leggere diversi articoli legati a questa tematica, legata alla ‘sincerità’, contrapposta alla ‘ipocrisia’; il ‘vero musulmano’, dunque, è colui/ei (secondo la narrativa dello SI) che emigra (sia fisicamente che spiritualmente) nelle terre del Califfato, e prende parte alla Jihad, un altro ‘dovere’ secondo ISIS e molti gruppi terroristi.
Sono stati moltissimi ad aver risposto a questo appello, e molti di essi erano dei convertiti, ovvero persone che non sono nate né musulmane e tantomeno in Paesi a maggioranza islamica; per questa ragione, la strategia dello SI può essere considerata globale. Successivamente, il ritorno di foreign fighters e la possibilità di attentati ‘domestici’ hanno reso tangibile l’idea che il nemico potesse essere interno, invisibile, nascosto nella vita quotidiana, e praticamene invisibile. Tale possibilità, di cellule e lupi solitari che operano in qualunque Paese, ha avuto un impatto psicologico e politico dirompente, ed è stata questa percezione (in parte giustificata) ad aver favorito l’adozione di misure di sorveglianza più invasive, il rafforzamento dei discorsi securitari e un clima sociale meno aperto verso la diversità culturale e religiosa.
Paure Collettive e Politiche Securitarie
Le stragi di Parigi del 2015, l’attacco al Bataclan, le esplosioni a Bruxelles del 2016, così come le violenze di Nizza, Berlino, Londra e Manchester, hanno rappresentato momenti di svolta nella percezione pubblica della minaccia jihadista. In queste circostanze, ISIS non è stato soltanto un attore militare, ma un potente generatore di simboli capaci di condizionare la psicologia collettiva, instillando una sensazione di minaccia costante.
Gli attentati hanno alimentato un clima di paura che, nei paesi europei, si è tradotto in un sostegno crescente a forze politiche conservatrici e nazionaliste; la promessa di sicurezza, di controllo delle frontiere e di limitazione dei flussi migratori è diventata una delle piattaforme più persuasive per partiti e leader di orientamento conservatore. La narrativa del pericolo islamista, in altre parole, ha contribuito a spostare il baricentro politico verso posizioni più rigide in tema di sicurezza, immigrazione e identità culturale.
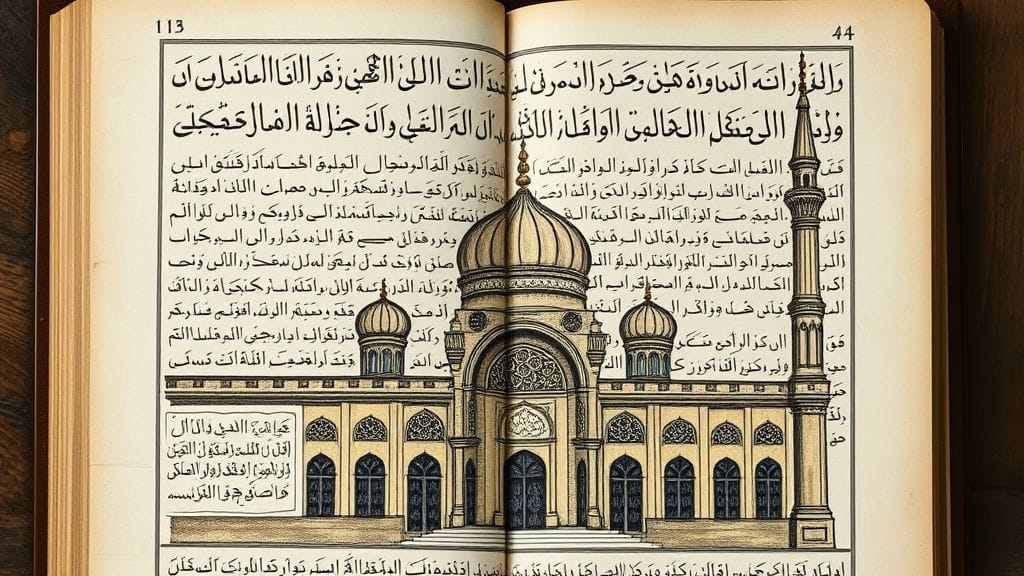
Si tratta, del resto, di politiche necessarie di fronte alla minaccia di un nemico che rimane invisibile, e, allo stesso tempo, visibile, e minaccia lo stile di vita e la visione del mondo occidentale; è proprio questa, in effetti, la guerra che è stata combattuta, un conflitto tra due visionei del mondo contrapposte e non riconciliabili.
Il Legame tra Terrorismo e Ondata Conservatrice
Non si può ridurre l’ondata conservatrice globale alla sola influenza di ISIS, ma si deve riconoscere che il gruppo jihadista ha avuto un ruolo catalizzatore da questo punto di vista; il suo radicalismo estremo ha offerto un ‘altro’, un nemico da cui prendere le distanze, rafforzando identità contrapposte. Nei paesi occidentali, la retorica (giustificata o meno) della cosiddetta ‘invasione islamica’ ha trovato terreno fertile grazie agli attentati e alle immagini diffuse da Daesh, Le esecuzioni spettacolari, la distruzione di simboli storici, l’imposizione di codici morali medievali hanno contribuito a far rivalutare alle società occidentali le loro relazioni con l’Islam, anche nelle componenti innocue e non radicali.
La straordinaria e inedita crudeltà delle immagini e dei filmati diffusi da ISIS (veri o presunti tali) hanno inciso sull’immaginario collettivo, fornendo ai movimenti conservatori e identitari argomenti concreti per legittimare il loro peso politico. La minaccia del jihadismo, in effetti, ha accelerato processi che erano già avviati, come il rafforzamento delle politiche di frontiera, la sfiducia crescente verso il multiculturalismo e la crescita di movimenti che rivendicano la difesa delle identità nazionali, sia in senso culturale che religioso.
Una presa di posizione identitaria estema come quella di ISIS, dunque, ha dato un notevole contributo alla riemersione di poltiche identitarie anche in Occidente, dopo decenni di propaganda che tendeva a delegittimare tutto quanto era ‘occidentale’, assegnandoli la colpa dei problemi del mondo intero. La crisi del movimento ‘woke’, da questo punto di vista, è un segno tangibile del mutato orientamento politico e sociale a cui ha contriuto lo Stato Islamico.
Conservatorismo nei Paesi Musulmani
Se nei paesi occidentali l’influenza di ISIS ha contribuito a un irrigidimento politico e sociale, nei paesi a maggioranza musulmana l’impatto è stato inverso e speculare; l’azione di Daesh, con la sua radicale reinterpretazione della shariah e il progetto del califfato, ha spinto numerosi governi musulmani a riaffermare con forza la propria legittimità, spesso adottando politiche più restrittive in materia religiosa e sociale.
Una rilevanza particolare, poi, la riveste la predicazione dei salafiti, che adottano un linguaggio in gran parte comune a quello dei jihadisti; la denigrazione dell’occidente, presentato come decadente, corrotto e corruttore, la ‘purificazione’ della fede islamica, e la negazione sistematica della democrazia e del pluralismo sono tematiche comuni adottate dai movimenti terroristici, e da ISIS in particolare. La differenza consiste nell’atteggiamento; generalmente, i salafiti non invocano (direttamente) la violenza o azioni politiche specifiche, mentre in ISIS la dimensione militare e violenta è evidente. I salafiti, in altre parole, rimangono su un piano dottrinale, e invitano ad una riforma interna della comunità islamica, una riforma spirituale, ma che, nondimeno, ha chiari risvolti politici.
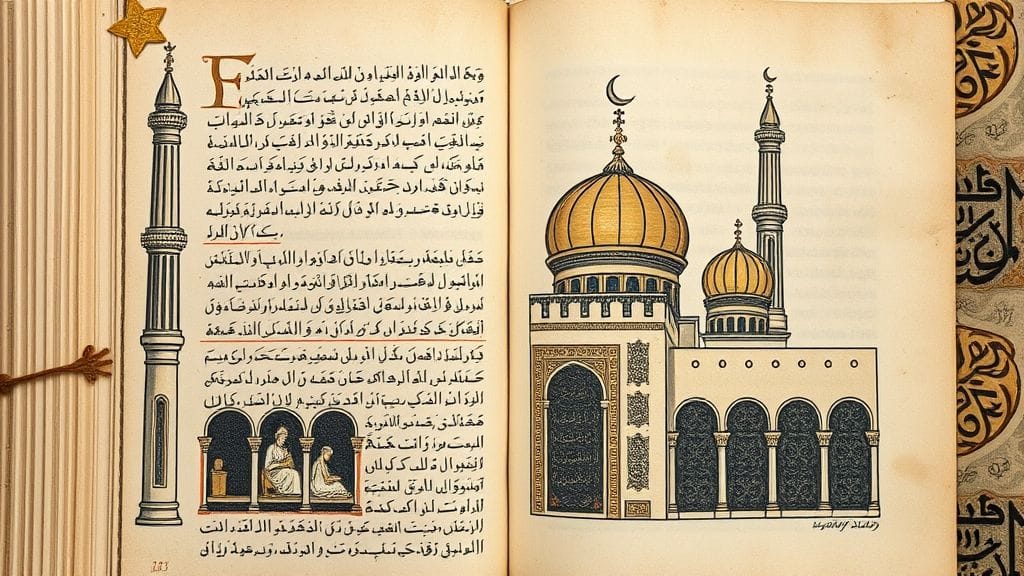
Nella sua opera, ‘Mulia Denghan Manaj Salaf’, ‘La Nobiltà della Via Salafi’, Jawas, uno dei predicatori indonesiani più noti della galassia salafita, afferma
Dan kewajiban yang kedua adalah tarbiyah (arabo, omissis), yaitu pembinaan generasi Muslim, di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan sebuah pembinaan secara Islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir.
E il secondo dovere è l’educazione (arabo, omissis), ovvero l’istruzione della generazione musulmana, basata sull’Islam purificato dalle cose menzionate sopra, con un’educazione islamica corretta fin dalla prima infanzia, senza essere influenzata dall’educazione occidentale miscredente.
La Nobiltà della Via Salafi, p. 330.
Si tratta di un piccolo, ma significativo esempio della propaganda salafita, in cui l’occidente viene associato alla miscredenza, e, dunque, ad un pericolo da esorcizzare mediante l’adesione (secondo questa logica) al ‘vero Islam’, debitamente ‘purificato’ dalla ‘nobile via/metodologia’ salafita.
Il timore di una penetrazione jihadista ha portato a un irrigidimento interno: maggiore controllo sulle moschee, sorveglianza capillare dei movimenti islamisti e, in alcuni casi, l’adozione di leggi ispirate a principi conservatori per neutralizzare il consenso potenziale di Daesh. Paradossalmente, il radicalismo jihadista ha favorito una ‘conservatorizzazione’ dei regimi, i quali, per distinguersi da ISIS, hanno finito per rafforzare le proprie credenziali religiose.
La Dimensione Culturale e Identitaria
Oltre alle politiche, l’influenza di Daesh si misura anche sul piano culturale, e, da questo punto di vista, si osserva che ISIS ha imposto un linguaggio visivo e simbolico che ha volutamente alimentato la polarizzazione. L’uso della bandiera nera, delle decapitazioni filmate, unitamente alle esecuzioni di massa hanno fissato nell’immaginario globale l’idea di un Islam irriducibilmente ostile. Questo ha favorito una narrazione binaria, in cui l’altro è percepito come minaccia esistenziale, senza distinguere tra la maggioranza non violenta e la minoranza radicalizzata.
La diffusione di questi simboli ha trovato eco nei movimenti conservatori e populisti, che li hanno utilizzati per sostenere la necessità di difendere i valori tradizionali e l’identità culturale europea; pertanto, la violenza di Daesh ha avuto un impatto che si estende oltre la sua capacità operativa. ISIS è dunque riuscita ad incidere profondamente sulla costruzione delle identità collettive e sulla percezione del mondo islamico.
ISIS ha dunque risvegliato, e legittimato nuovamente, sentimenti e approcci che in precedenza erano giudicati inadeguati dal punto di vista politico o sociale; del resto, non si comprende la ragione per cui affermare l’identità europea sarebbe problematica, mentre sostenere quella altrui (spesso islamica) non lo sarebbe.
Conclulsione – Scenari futuri
Attualmente, ISIS non possiede più la forza territoriale che dominava Mosul o Raqqa, ma la sua influenza sopravvive in forme diverse e frammentate; nelle regioni africane (dal Sahel al Mozambico) e nel Sud-est asiatico (dalle Filippine all’Indonesia) sono operative cellule e gruppi affiliati che continuano ad agire, mantenendo viva la minaccia jihadista. Oltre la dimensione operativa, tuttavia, l’eredità (e la presenza, seppure ridimensionata) di Daesh è anche e soprattutto culturale e politica.
L’ondata conservatrice (sia in Occidente che nel mondo islamico), pur radicata in dinamiche più ampie, ha trovato in ISIS un acceleratore; la paura generata dal jihadismo ha reso accettabili misure e discorsi che in precedenza sarebbero apparsi sproporzionati. Nel lungo periodo, questo significa che l’impatto del Califfato non si misura soltanto in termini di vittime o territori, ma anche nella capacità di aver spostato gli equilibri ideologici a livello globale.
L’esperienza di ISIS, in definitiva, dimostra come un attore violento e relativamente circoscritto possa produrre conseguenze molto più ampie rispetto alla propria dimensione militare; attraverso la violenza spettacolare, la manipolazione dei simboli e la diffusione di un’ideologia totalizzante, Daesh ha influenzato non solamente le dinamiche interne al mondo musulmano, ma anche l’evoluzione delle società occidentali.
La risposta securitaria, l’irrigidimento identitario e la crescita delle forze conservatrici in diversi contesti dimostrano che la minaccia jihadista non si esaurisce sul campo di battaglia, ma si riverbera nelle strutture profonde delle società. L’ISIS, seppure ridimensionato, continua dunque a vivere come spettro politico e culturale, capace di condizionare le traiettorie future delle relazioni tra Islam e Occidente, tra sicurezza e libertà, tra apertura e chiusura identitaria.
Letture Consigliate
- Abdul Muhyi Tajudin & Muhammad Adi Saputra. (2025). ISIS and the clash of interests among global political, economic, and social actors. Journal of Islamic History and Cultural Research, 1(1), 29.
- Andri Rosadi. (2022). Deprived Muslims and Salafism: An ethnographic study of the Salafi movement in Pekanbaru, Indonesia. Religions, 13(10), 911.
- Mahmut Cengiz, Kutluer Karademir, & Huseyin Cinoglu. (2022). The ISIS model and its influence over global terrorism. European Scientific Journal, ESJ, 18(7), 14.