- Introduzione – La Musulmanità
- Le Radici Storiche di una 'Pluralità Islamica'
- La Reformasi e l’Esplosione della Politica Islamista
- Aceh – Un’Isola di Sharia nell’Arcipelago Democratico
- Il Caso Ahok – La Musulmanità come Arma Politica
- Contraddizioni e Tensioni Democratiche
- Conclusione
- Letture Consigliate
In questo articolo propongo una categoria, la ‘musulmanità’, per indicare un costrutto politico e sociale preciso, una percezione pubblica dell’identità islamica che condiziona la vita politica e sociale, come si vede chiaramente in Indonesia.
In this article, I propose the category of ‘Muslimness’ to indicate a specific political and social construct, a public perception of Islamic identity that influences political and social life, as is clearly seen in Indonesia.
Introduzione – La Musulmanità
Il termine musulmanità che propongo come categoria socio-politica, rappresenta un tentativo di interpretare e descrivere una realtà oltre la semplice appartenenza religiosa; si tratta di un vocabolo con cui intendo rendere il concetto di ‘islamicness’, di identità islamica in senso ampio. In questo caso, mi riferisco ad una sorta di condizione sociale e politica che plasma le società a maggioranza musulmana, conferendo ai sistemi di potere un orizzonte di senso e un linguaggio comune. Non si tratta semplicemente di fede personale o di identità culturale, ma di un vero e proprio ‘campo magnetico’ capace di orientare e definire i confini e le norme (implicite) dell’arena pubblica. Nei Paesi a maggioranza islamica, l’Islam (sia sunnita che sciita) non rappresenta solamente una religione, ma un orizzonte culturale e sociale che non può essere ignorato, anche (e specialmente) dalle minoranze.
Un esempio della rilevanza di questa condizione è rappresentata dall’Indonesia, il più grande Paese islamico del mondo,che rappresenta un caso privilegiato per osservare come la musulmanità operi nella vita politica. Qui essa non si manifesta come dominio esclusivo della religione, e nemmeno come semplice residuo identitario, ma come un terreno di negoziazione costante tra le spinte pluraliste, desiderose di preservare la diversità, e le forze conservatrici che aspirano a un ritorno a forme più rigide di normatività islamica. La democrazia indonesiana, nata dalle ceneri del regime autoritario di Suharto, è quindi attraversata da una tensione permanente, la cociliazione del pluralismo proclamato con le pretese identitarie di una musulmanità che non accetta di restare confinata alla sfera privata.
Le Radici Storiche di una ‘Pluralità Islamica‘
L’Islam approdò nell’arcipelago indonesiano, principalmente, non attraverso la conquista militare (che però ci fu in alcuni casi), ma lungo le rotte marittime e commerciali che collegavano l’Oceano Indiano; predicatori sufi, mercanti provenienti dall’India e dall’Arabia, studiosi itineranti portarono un Islam (generalmente) più flessibile rispetto a quello ‘arabo’, capace di integrarsi (in una certa misura) con le credenze e le pratiche locali. A Java, antichi rituali induisti-buddhisti si mescolarono con le pratiche islamiche; a Sumatra, confraternite sufi come la Shattariyya e la Qadiriyya crearono legami comunitari che favorirono un Islam meno dogmatico, spesso più spirituale che giuridico. La provenienza indiana dell’Islam indonesiano, in effetti, sembra essere l’ipotesi più credibile tra quelle che vengono avanzate, e spiega il suo carattere sufi.
La proclamazione dell’indipendenza nel 1945 rese il dilemma evidente, e ci si chiese se lo Stato dovesse avere uno statuto islamico vero e proprio; alcuni nazionalisti chiedevano che la nuova Repubblica avesse come fondamento la shariah, mentre i leader pluralisti temevano che ciò avrebbe alienato le minoranze cristiane, indù e buddhiste. La soluzione fu un compromesso, la Pancasila, che riconosceva la fede in un Dio unico ma senza identificare l’Islam come religione ufficiale; si trattava (e rimane) di un patto fragile, ma permise di tenere insieme un arcipelago formato da molti gruppi etnici e religiosi.
Questo apparente equilibrio, tuttavia, non sopì le aspirazioni di una parte consistente dei musulmani indonesiani, che rifiutarono di usare la forza per introdurre la sharia negli spazi pubblici, ma continuarono a lottare nelle sedi politiche per raggiungere questo obiettivo. Altri gruppi, come Darul Islam, invece, scelsero la strada del conflitto aperto e armato con lo Stato, che ritenevano incapace di soddisfare le esigenze della maggioranza islamica del Paese asiatico. Questi movimenti sono classificati come terroristici (e non a torto), ma sembra più corretto considerarli insorgenti, in quanto la componente politica è evidente e dominante rispetto alle semplici aspirazioni religiose.
La Reformasi e l’Esplosione della Politica Islamista
La caduta di Suharto nel 1998, dopo circa trentadue anni di autoritarismo, inaugurò una nuova stagione democratica; per la prima volta dall’era parlamentare di Soekarno (le prime e ultime elezioni libere si erano svolte nel 1955, con risultati inconcludenti) la società civile si espresse con maggiore libertà. Fu in tale contesto che nacquero nuovi partiti politici, mentre le organizzazioni religiose acquisirono un ruolo centrale nella vita del Paese.
I nuovi spazi di libertà, tuttavia, furono sfruttati anche da correnti e gruppi che erano stati marginalizzati dal regime di Soeharto; per questa ragione, gruppi islamisti, predicatori radicali e movimenti giovanili religiosi emersero con forza. Il discorso pubblico, da laico e nazionalista, si riempì di simboli islamici, e le moschee divennero (nuovamente) luoghi non solamente per la preghiera ma anche e soprattutto per la mobilitazione politica e sociale. Le università, poi, si trasformarono in spazi di contesa ideologica, mentre i media concessero ampio spazio a predicatori televisivi che proponevano un Islam moralizzatore e conservatore.
L’Indonesia, da laboratorio di pluralismo, si ritrovò anche campo di battaglia del revival islamico, le strade di Giacarta iniziarono a riempirsi di donne velate, un fenomeno in forte crescita dagli anni Duemila, e le discussioni su ciò che era ‘hala’o ‘haram’ acquistarono un peso crescente nel dibattito pubblico e nella vita quotidiana. La musulmanità, dunque, si era trasformata da identità silenziosa a identità militante, capace di orientare le coscienze e il voto degli elettori nella cabina elettorale.
Rimane emblematico il caso di Islam Jamaah, un gruppo islamico dichiarato deviato dal governo nazionale, allo scopo, probabilmente, di ricondurre le attività religiose sotto l’egida del Orde Baru, al pari di quanto si osserva per altri movimenti e partiti, non necessariamente islamici, in questo periodo storico.
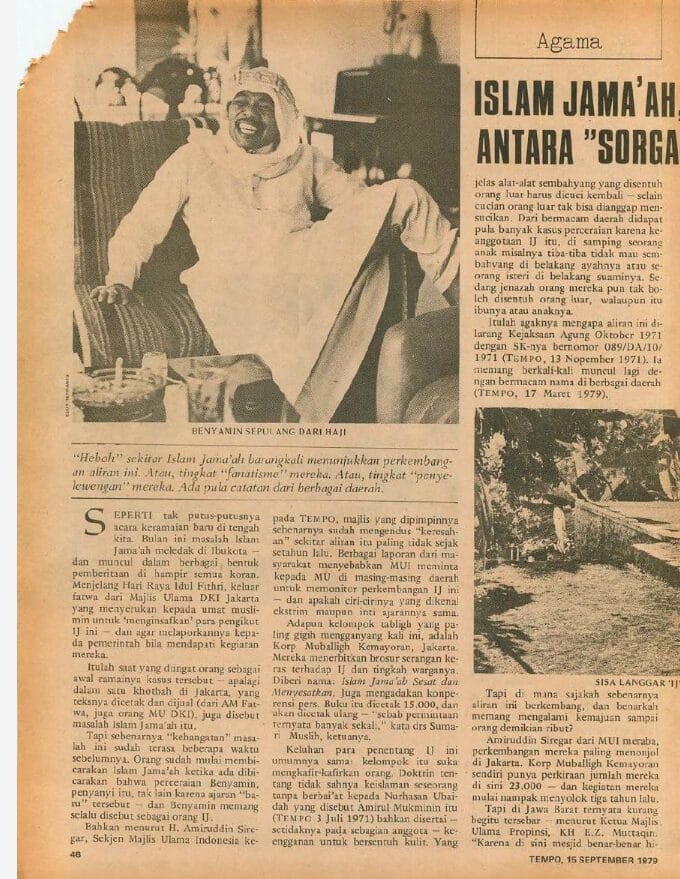
Sebbene IJ presentasse alcuni caratteri di una setta vera e propria, la sua dissoluzione da parte del governo non è stata motivata da fattori religiosi, ma politici, in quanto si presumeva (secondo le accuse) che tale associazione minacciasse l’unità nazionale.
Aceh – Un’Isola di Sharia nell’Arcipelago Democratico
Nessun luogo incarna meglio questa ambivalenza di Aceh, la provincia più settentrionale di Sumatra, in cui si osserva una lunga storia di autonomia e di ribellione ai tentatiti esterni di controllo; dopo l’indipendenza, e le polemiche verso i governi nazionali, si è svolto un lungo conflitto separatista, culminato con gli accordi di pace del 2005. In base a questi accordo, Aceh rinunciava a diventare indipendente dall’Indonesia, ma poteva applicare la sharia nel territorio provinciale, come si è già discusso su questa rivista.
Da allora, Aceh vive sotto un ordinamento giuridico speciale, dettagliato dai ‘qanun’, regolamenti provinciali con cui si conferisce alla sharia uno statuto legale, alternativo a quello nazionale; in altre parole, vengono previsti reati (e relative punizioni) che non si aggiungono, ma si sostituiscono alla legge nazionale. Uomini e donne possono essere frustati pubblicamente per adulterio, consumo di alcol, gioco d’azzardo o comportamenti ritenuti indecenti, mentre la polizia religiosa pattuglia strade e mercati, imponendo codici di abbigliamento e sorvegliando le relazioni sociali.
Per i sostenitori locali, questa è l’espressione autentica dell’identità acehnese, un riscatto dopo decenni di marginalizzazione; per i critici, invece, si tratta di una palese contraddizione rispetto al resto del Paese, che si definisce democratico laico e pluralista. In questo caso, la musulmanità non rimane una condizione latente o inespressa, ma viene codificata mediante leggi e un intero apparato legale e giudiziario.
Aceh, del resto, vanta una lunga tradizione in questo senso, e la legittimazione della leadership si esprime proprio adottando forme visibili e ‘emotive’ della sharia, la cui applicazione è comunque limitata; non sono previste le sanzioni più gravi previste dalla legge islamica, come l’amputazione degli arti o la lapidazione, pene invece previste da gruppi terroristici come Daesh/ISIS. Per queste ragioni, la sharia assume un’evidente connotazione politica, piuttosto che religiosa, e serve a giustificare, almeno in parte, la perdita dell’indipendenza politica.
Il Caso Ahok – La Musulmanità come Arma Politica
Uno degli episodi che ha reso visibile ed esplicita la forza della musulmanità in Indonesia è il ‘caso Ahok’, Basuki Tjahaja Purnama, governatore cristiano di Giacarta di origine cinese, che divenne oggetto di una campagna massiccia dopo un commento interpretato come irriverente, blasfemo, verso un versetto coranico.
Quello che poteva sembrare un malinteso si trasformò presto in un vero e proprio terremoto politico; furono centinaia di migliaia di persone a manifestare a Jakarta, guidate dal Front Pembela Islam (FPI), per chiedere la condanna del governatore ‘blasfemo’. I cortei, connotati da slogan religiosi radicali e un’enorme mobilitazione popolare, costrinsero i tribunali a processarlo e a condannarlo a due anni di carcere per blasfemia nel 2017.

Questo episodio non fu tanto una vicenda giudiziaria, quanto una lezione politica, segnata dall’uso e dall’influenza della musulmanità, che, intesa come sensibilità e aspetttive collettive della maggioranza, poteva essere mobilitata per squalificare un leader e piegare le istituzioni democratiche, pur in assenza di una legge che vietasse ad un cristiano di ricoprire la carica di governatore. La blasfemia venne nuovamente usata come arma di lotta politica, mostrando quanto fragile fosse il compromesso tra pluralismo e identità islamica.
Contraddizioni e Tensioni Democratiche
La vita politica indonesiana è un mosaico di contraddizioni, e, in effetti, il Paese organizza elezioni libere, ha una società civile vivace, conosce una pluralità di partiti e associazioni; allo stesso tempo, si assiste ad una serie di episodi di discriminazione contro minoranze religiose, che non sono casi isolati. Accade con una certa frequenza che le chiese vengano chiuse dalle autorità locali, o che gli attivisti per le libertà civili vengano intimiditi.
La musulmanità agisce dunque come un vincolo non solamente pratica, ma anche discorsivo, e nessun politico può permettersi di ignorarla; per questa ragione, anche i partiti laici sono costretti ad adottare retoriche islamiche. I candidati si presentano spesso vestiti con abiti tradizionali musulmani, partecipano a pellegrinaggi o si mostrano accanto a ulema influenti; il pluralismo rimane, ma deve sempre essere negoziato con una condizione identitaria che pretende un continuo ed esplicito riconoscimento.
Questa tensione, del resto non si sviluppa in un vacuum, in quanto l’Indonesia è attraversata da correnti globali, come il salafismo importato dall’Arabia Saudita attraverso borse di studio e fondazioni, la retorica jihadista diffusa online, e la rete dei Fratelli Musulmani che dialoga con attivisti locali. La musulmanità indonesiana è dunque parte integrante di una geografia più ampia, che lega Giacarta a Riyadh, al Cairo e a Islamabad, in una rete di solidarietà islamica.
L’Indonesia rimane, nonostante tutto, una democrazia funzionante. Le elezioni sono regolari, la società civile è attiva, le istituzioni non hanno ceduto del tutto alle pressioni islamiste. Ma il compromesso è instabile: la musulmanità continua a essere al tempo stesso risorsa di legittimità e minaccia alla libertà.
Il futuro dipenderà dalla capacità del Paese di conciliare le due anime che la abitano, quella pluralista, erede della Pancasila, e quella conservatrice, spinta dal desiderio di un ritorno a un Islam pubblico più normativo e visibile.
Conclusione
Parlare di musulmanità significa riconoscere che l’Islam non è solo religione ma anche (e spesso soprattutto) un orizzonte politico e culturale; in Indonesia questo discorso si traduce in un conflitto permanente tra apertura democratica e spinte identitarie. Il caso di Aceh e la vicenda di Ahok, in effetti, mostrano quanto sia profonda l’influenza della musulmanità sulla politica, non come opzione ideologica, ma come condizione che non può essere ignorata da nessuno.
Attualmente, l’Indonesia rappresenta un laboratorio sociale e politico molto interessante, in cui si misura la possibilità di una democrazia islamica di massa, capace di resistere alle pressioni conservatrici senza rinunciare alla sua identità. Se riuscirà a mantenere questo equilibrio, il Paese asiatico potrà offrire un modello inedito al mondo islamico; se fallirà, invece, dimostrerà che la musulmanità, lasciata senza argini, può trasformarsi da terreno comune a strumento di esclusione e conflitto.
Letture Consigliate
- Rahman, A., Riyani, M., & Shamadiyah, N. (2024). Islamic Identity in Aceh Shaped by the Historical and Cultural Heritage of the Perlak Sultanate. IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 22(1), 57-72.
- Pribadi, Y. (2022). Sekolah Islam (Islamic schools) as symbols of Indonesia’s urban Muslim identity. TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia, 10(2), 203-218.
- Fakhrurrazi, F., Zainuddin, Y., & Zulkarnaini, Z. (2021). The pesantren: Politics of islamic and problematic education muslim identity. International Journal for Educational and Vocational Studies, 3(6), 392-396.

